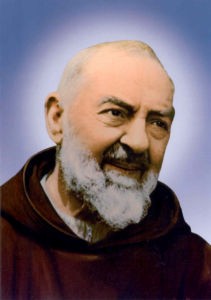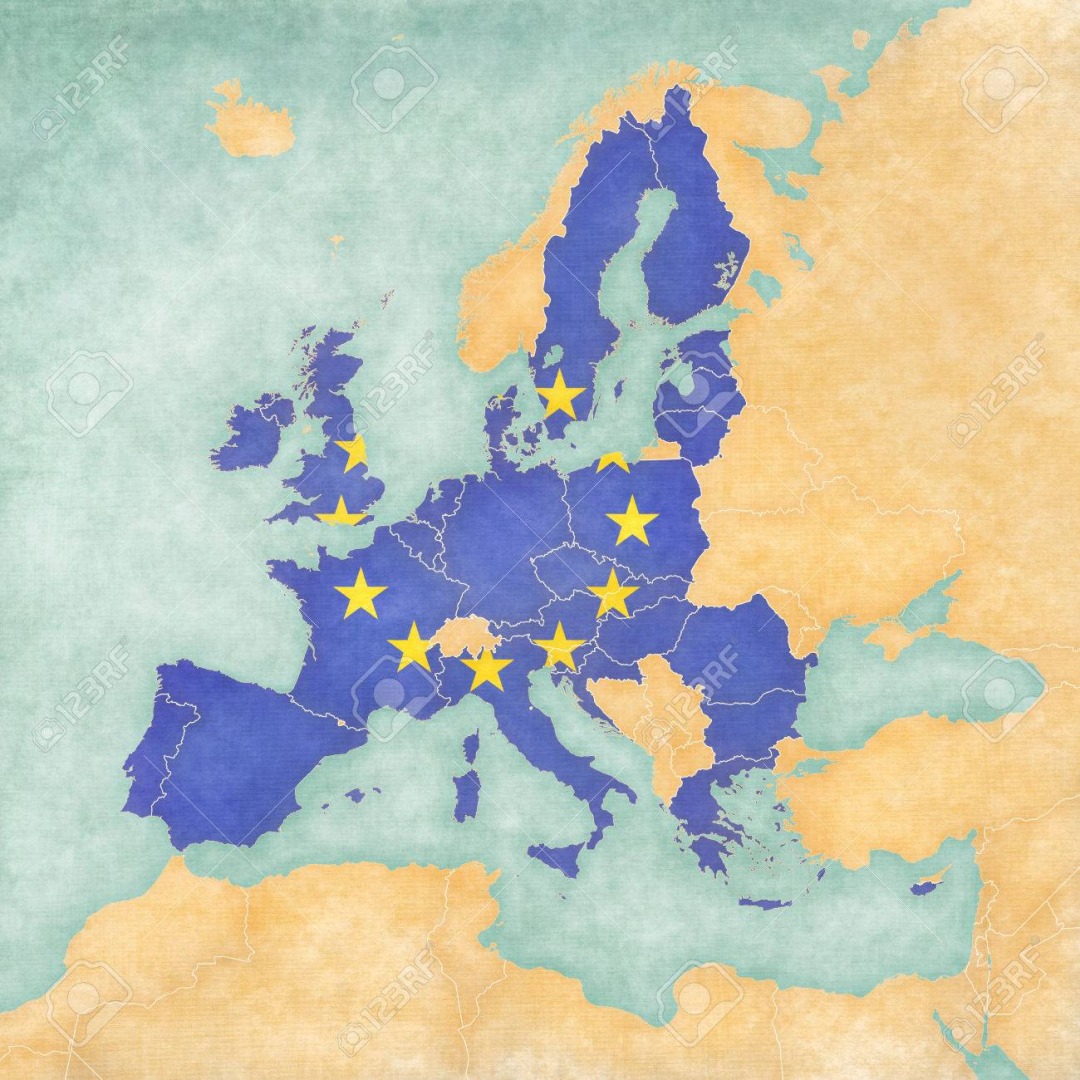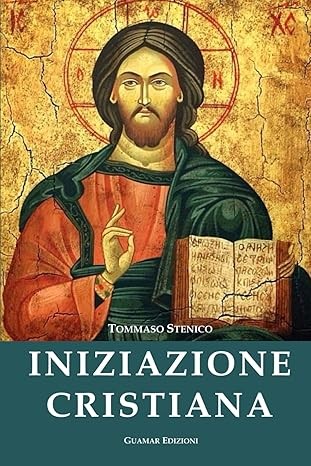di Guglielmo Di Burra
L’episodio di Torino non è una sorpresa. È l’ennesima cronaca di un fatto annunciato, scritto da tempo e lasciato lì a maturare nel silenzio complice di chi continua a confondere la tolleranza con l’assenza di regole. A farne le spese sono state le Forze dell’ordine, costrette a fronteggiare una vera guerriglia urbana, e alcuni giornalisti, aggrediti mentre svolgevano il loro lavoro, insieme a ignari cittadini danneggiati, che hanno pagato il prezzo di una violenza cieca e deliberata. Un poliziotto aggredito e preso a calci, pugni e martellate durante una manifestazione non è un incidente, non è una deviazione improvvisa, non è sfortuna. È il risultato diretto di anni di lassismo, di messaggi ambigui, di leggi svuotate e di un relativismo cialtrone che ha trasformato tutto in opinabile, perfino la violenza.
Condannare l’aggressione è il minimo indispensabile. Farlo senza giri di parole è un dovere. Chi indossa una divisa in piazza non rappresenta un’idea da contestare ma lo Stato che garantisce a tutti, manifestanti compresi, di poter tornare a casa illesi. Quando quel confine viene superato, non siamo davanti a una protesta accesa ma a un atto criminale. Definirlo in altro modo è una presa in giro.
A rendere il quadro ancora più grottesco è la povertà delle motivazioni della manifestazione di ieri. L’accusa allo Stato nasce dal fatto di aver legittimamente liberato uno stabile occupato da oltre trent’anni dal centro sociale Askatasuna per restituirlo ai legittimi proprietari. Tradotto senza troppi giri di parole: un immobile illegittimamente sottratto per decenni a chi ne ha titolo, le istituzioni intervengono per ripristinare la legalità, e questo viene raccontato come un abuso. Siamo a un rovesciamento completo della realtà, dove il diritto diventa “violenza” e l’illegalità diventa “resistenza”.
Qui non c’è alcun sopruso. Difendere la legalità è un dovere. C’è il rispetto della legge e del diritto di proprietà, principi basilari di qualsiasi Stato che si definisca tale. Pretendere di preservare un’occupazione trentennale come se fosse un diritto acquisito significa aver perso ogni bussola. Significa aver normalizzato l’idea che la forza del fatto compiuto conti più delle regole comuni. Ed è esattamente questo che avvelena il clima e prepara il terreno alla violenza.
Poi c’è il paradosso finale, quello che ormai è diventato il riflesso automatico di una certa narrazione gravemente tossica: chiunque provi a ristabilire il rispetto delle leggi diventa, per definizione, un “fascista reazionario” da abbattere. Non da contestare, non da criticare, proprio da eliminare simbolicamente, screditare, intimidire. È un meccanismo allucinante e comodo. Se la legge ti smentisce, allora non è la tua posizione ad essere sbagliata: è lo Stato a essere “oppressivo”, chi applica le regole è “nemico”, e la violenza diventa quasi un passaggio obbligato, una specie di certificato morale. È così che si costruisce la giustificazione perfetta per qualunque aggressione.
Da troppo tempo si tollera l’idea che l’illegalità sia una forma di espressione e che l’aggressione sia una reazione comprensibile. È qui che nasce il problema. Le regole non sono un’opzione morale, sono un patto. E un patto che vale solo quando fa comodo non è più un patto, è una farsa. Il buonismo urlato ha eroso l’autorità, ha legittimato l’insulto, ha sdoganato lo scontro fisico come linguaggio politico. Poi ci si stupisce quando qualcuno passa dalle parole ai pugni.
C’è una responsabilità culturale enorme dietro questi episodi. Anni di narrazioni in cui chi garantisce l’ordine viene dipinto come un bersaglio e chi lo attacca trova sempre una scusa pronta all’uso. Il risultato è una piazza dove la linea rossa non esiste più e dove la violenza si sente autorizzata. Non è rabbia: è impunità percepita.
Se non si ristabiliscono regole chiare, sanzioni certe e un principio semplice, chi alza le mani paga, questi episodi continueranno. Non per caso, ma per coerenza. Se smantelli l’autorità, se relativizzi l’applicazione della legge, se infantilizzi la responsabilità individuale, eccoti servito il conto. Sempre lo stesso, sempre più salato.
Esternare solidarietà piena al poliziotto aggredito è il minimo che un Presidente della Repubblica e un Capo del Governo possano fare, mentre sarebbe ora di chiederci se vogliamo continuare a raccontarci favole oppure vogliamo rimettere in piedi uno Stato che sappia fare lo Stato. La risposta non sta nelle parole di circostanza del giorno dopo, ma nelle scelte concrete di oggi.