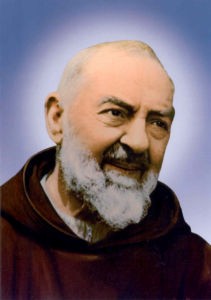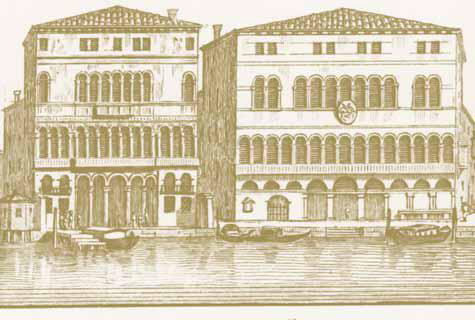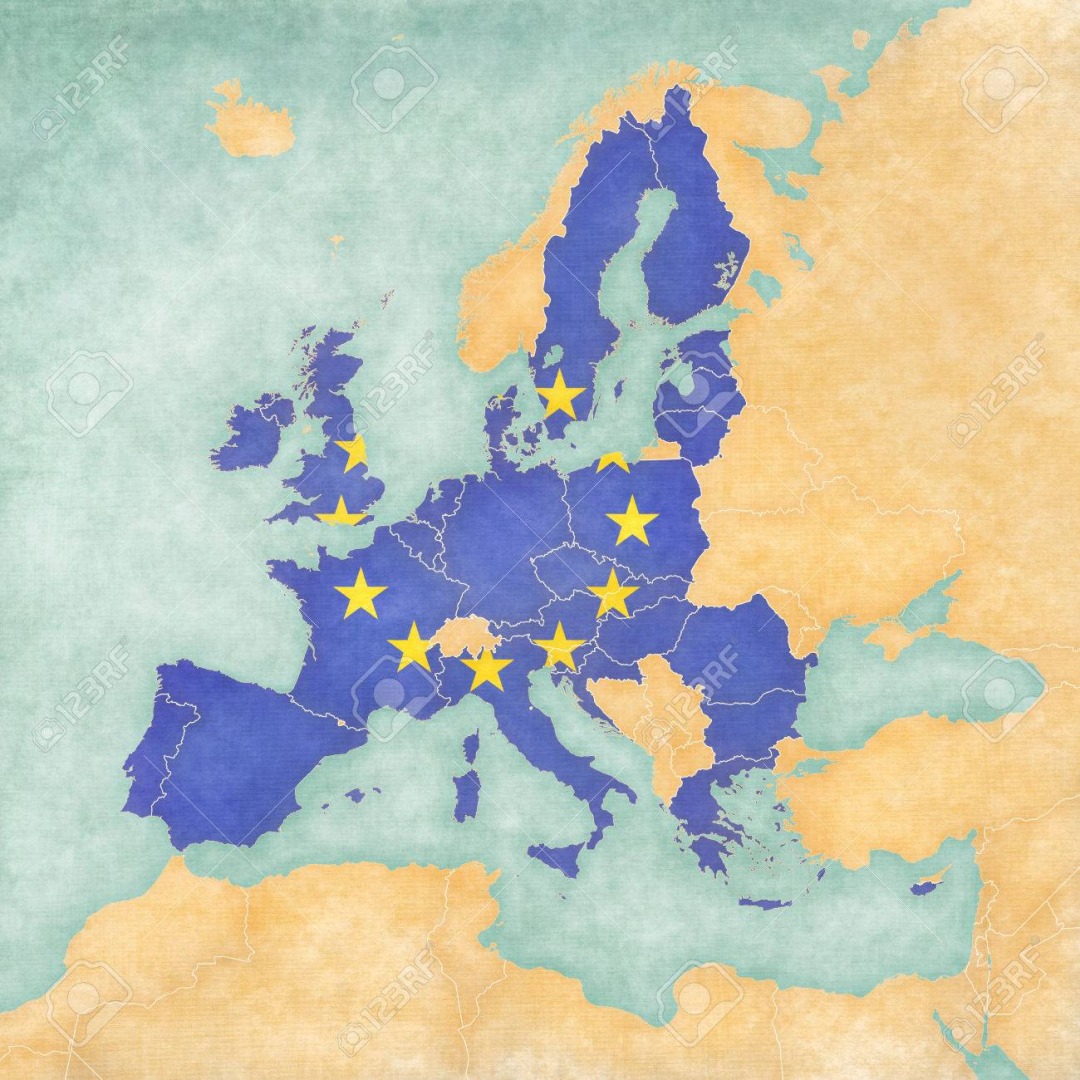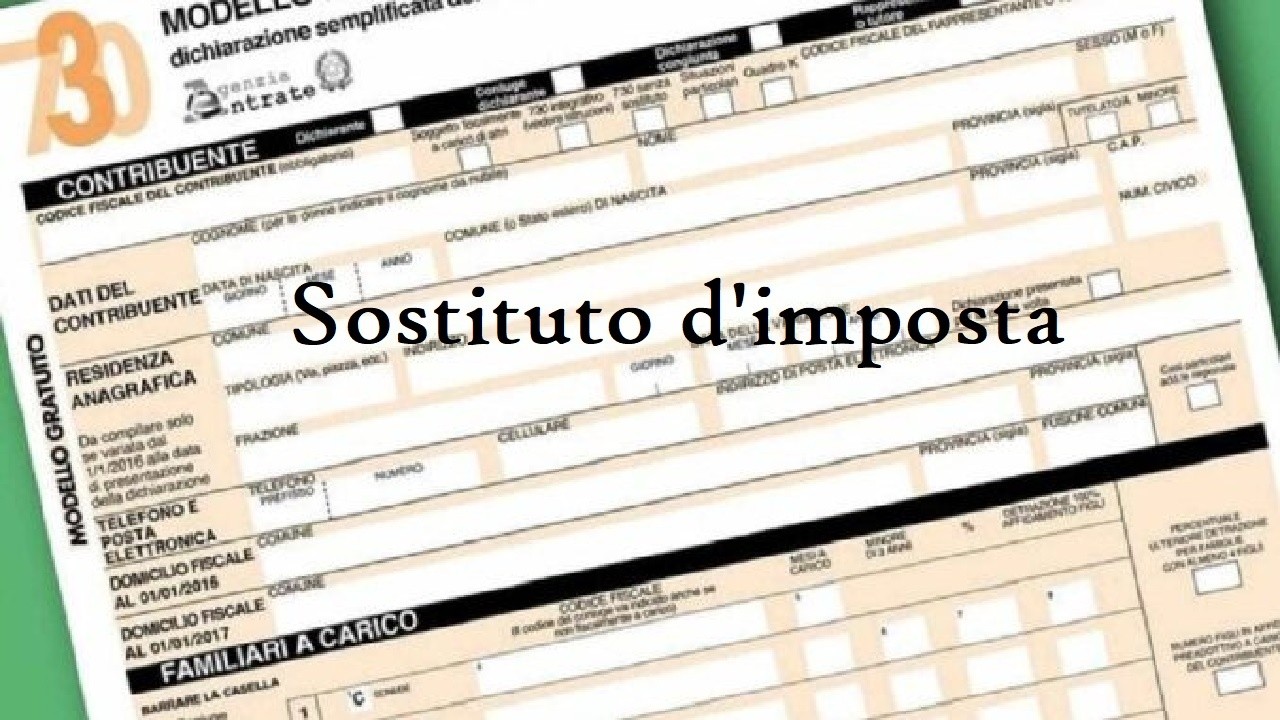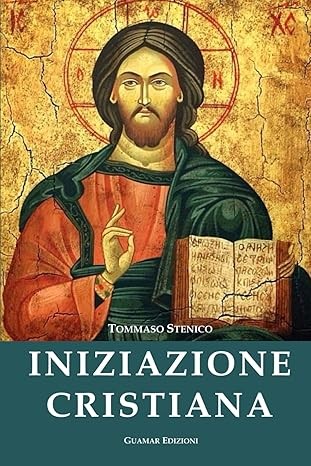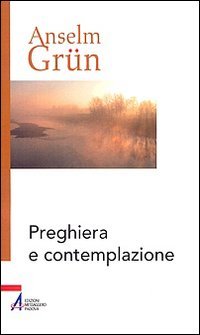LA COSTITUENTE EUROPEA TRA SPERANZE E TIMORI NELLE TRATTATIVE TRA GLI STATI E DENTRO GLI STATI
Il periodo politico che seguì alla firma del Trattato per la Comunità Europea di Difesa mise in evidenza quanto la visione unitaria europea fosse nelle menti e nei cuori dei leader nazionali, ma meno nelle compagini parlamentari. Per motivi diversi ogni parlamento affrontò la questione della ratifica del trattato con le proprie difficoltà ed incertezze.
Da parte francese i primi dibattiti interni riguardavano quanto fosse stato modificato dalla prima bozza del piano Pleven. La versione finale del Trattato CED aveva fortemente indebolito la proposta iniziale a favore di obiettivi delle singole nazioni ma soprattutto non era emersa quella linea che puntava ad escludere anche la ricostituzione di un esercito tedesco e garantire un controllo efficace del riarmo della Germania, nodo essenziale per la Francia.
L’incertezza politica, le vicine elezioni in Germania e in Italia, l’attesa della ratifica da parte degli altri stati, sono alcuni dei principali motivi che ritardarono l’analisi e l’approfondimento nei vari consessi parlamentari della documentazione del Trattato. Non secondaria risultava inoltre la necessità che per rendere efficace il Trattato CED, servisse modificare le disposizioni di Bilancio e gli organici del personale della Difesa e anche questa impostazione, nell’incertezza generale divenne un freno sostanziale.
Anche a livello italiano, alcuni esponenti del Governo si esprimevano in modo critico sulle ipotesi di trasferire quote di bilancio a enti sovranazionali o nell’aumentare la spesa per la difesa. In Italia rimaneva inoltre all’ordine del giorno la questione di Trieste, dove i rapporti italo-jugoslavi si inserivano nelle inevitabili implicazioni che un eventuale esercito europeo avrebbe potuto avere sul fronte orientale italiano.
Mentre si discuteva nelle sedi nazionali della ratifica della CED, la Comunità Politica europea (CPE) diveniva un argomento strettamente attuale. L’articolo 38 inserito nel Trattato, fortemente voluto da De Gasperi, segnava infatti un cambio di passo nel processo d’integrazione europeo che lo stesso De Gasperi, nella seduta del Senato del 1° aprile 1952, così descrisse: “... dalla primitiva ricerca di mezzi per raf orzare la difesa dell'Occidente, si è a poco a poco venuto delineando un obiettivo ben più ampio: la realizzazione dell'unità europea e l'abolizione degli storici conflitti che da secoli dilaniavano l'Europa occidentale. Conflitti che in un mondo così strettamente legato ed interdipendente quale è quello moderno, erano ormai divenuti vere e proprie guerre civili. Il Governo italiano è fiero di aver potuto portare alla costruzione il suo contributo, ef ettivo e da tutti apprezzato, ottenendo che fosse inserito nel progetto di Trattato l'incentivo per la creazione della Federazione europea, i cui organi saranno ispirati alle tradizioni democratiche e parlamentari comuni ai sei Paesi partecipanti.”. E sempre De Gasperi spiegava che: “Il Trattato prevede, infine, che l'Assemblea, entro sei mesi dalla sua entrata in funzione, prepari un progetto per la trasformazione della Comunità in un organismo federale basato sul sistema bicamerale e la divisione dei poteri. Sarà quindi un'Assemblea con veste di pre-Costituente europea. Non appena il progetto sarà pronto esso sarà inviato ai Governi che dovranno, entro tre mesi, convocare una Conferenza allo scopo di dar vita alla Federazione europea. Se entro un anno dalla sua convocazione, la Conferenza non sarà pervenuta ad un accordo, gli Stati membri procederanno di intesa a rivedere la composizione dell'Assemblea della Comunità.”.
Un percorso quindi ben delineato ma che nelle difficoltà della ratifica del trattato CED necessitava di una presa di posizione politica perché non andasse persa l’occasione. De Gasperi, anche sulla spinta del Movimento Federalista Europeo - MFE e di Altiero Spinelli, propose che fosse la già costituita Assemblea della CECA a trattare quanto previsto nell’articolo 38 del Trattato della CED. Infatti Spinelli, che aveva un ruolo di riconosciuto prestigio all’interno del movimento federalista Europeo, pubblicò un memorandum in cui si sottolineava che la costituzione di una forza militare comune non sarebbe stata possibile senza una corrispondente cessione di sovranità da parte degli Stati membri; un primo Stato federale a cui sarebbe spettata la guida delle forze militari e delle linee determinanti in politica estera.
Con un’azione rivolta in particolare verso il Governo francese, al quale De Gasperi guardava con estremo favore nella consapevolezza che l’asse franco-italiano potesse essere determinante per sbloccare la situazione, la diplomazia si mosse dal febbraio 1952 in modo convinto. I mesi successivi videro continui cambi di velocità sul tema federativo in quanto anche in Francia la situazione politica interna era da poco mutata con un rafforzamento, dopo le elezioni del 1951, dei comunisti e dei gollisti che si erano sempre espressi in modo negativo in particolare sul Piano Schuman.
Un parlamento francese che faticava ora a rimanere nel solco dell’europeismo quando invece lo aveva contraddistinto fino ad allora, rischiando di vanificare tutto il lavoro politico costruito dai propri leader di governo. La Germania di Adenauer era favorevole ad anticipare la Costituente Europea e in tal senso si mosse, ma gli alleati non vedevano strategicamente di buon grado questa presa di posizione in quanto avrebbe
potuto ulteriormente rafforzare le posizioni antieuropeiste all’interno dei singoli stati. La Gran Bretagna tramite il Ministro degli esteri Eden, nel marzo 1952, propose un piano alternativo che cambiava ulteriormente i progetti in corso perché pur cercando di sbloccare lo stallo ipotizzando una fusione delle Autorità specializzate con il Consiglio d’Europa, avrebbe cambiato le impostazioni istituzionali previste dall’articolo 38.
La discussione formale ed informale procedeva con difficoltà ma De Gasperi era sempre più convinto che la strada intrapresa fosse l’unica da percorrere, come si evince da questo telegramma che inviò a Parigi e Londra nel luglio del 1952: “... Considerando anche la reazione del ministro Eden alle comunicazioni che gli sono state fatte da Schuman circa la proposta franco-italiana tendente ad attribuire all’Assemblea della CECA il mandato dell’art. 38 della CED (suo telegramma n. 616 e telegramma ministeriale n. 477) ed il passo di Van Zeeland potrebbe essere la prima conseguenza di tale reazione sembra essere ancora più opportuno che si insista sulla anticipata applicazione dell’articolo stesso attraverso l’Assemblea della CECA; su tale articolo infatti esiste già un accordo dei sei Governi di cui anche gli inglesi sono da tempo al corrente. Anche perché nuove proposte le quali darebbero origine a delle controproposte potrebbero avere degli ef etti dilatori e costituire di fatto un indebolimento dell’iniziativa. A noi sembra invece che la decisione di anticipare l’applicazione dell’art. 38 si intoni perfettamente allo spirito dell’articolo stesso e che essa non contrasti con le finalità della proposta britannica, quale è stata da noi interpretata sulla base delle ripetute dichiarazioni di Eden che cioè essa non avrebbe dovuto intralciare lo sviluppo normale della Comunità europea”
La discussione tra le 6 nazioni procedette fino alla data storica del 10 settembre 1952 quando De Gasperi otteneva, senza ulteriori rinvii, l’approvazione del documento di accordo che prevedeva che l’Assemblea della CECA avrebbe dovuto in sei mesi, elaborare un progetto di statuto istituente una Comunità politica Europea. Le sue indicazioni andavano poi a delineare quanto lo statuto avrebbe dovuto contenere dal punto di vista generale e quindi quali competenze sarebbero state affidate all’autorità politica europea, in particolare sul tema della difesa comune ma non solo, in quanto riteneva che il sodalizio militare non sarebbe stato efficace senza un lavoro comune su economia, lavoro e mercato unico.
Dopo la firma dell’accordo De Gasperi si recò, per la prima volta dalla fine della guerra, in Germania ormai solido alleato europeista e con Adenauer grande amico dell’Italia nella costruzione federalista. Il 24 settembre gli venne conferito il Premio Carlo Magno e in quell’occasione ebbe parole di elogio per il percorso che sembrava avesse raggiunto un prima meta fondamentale: “Noi siamo qui nella suggestione di una grande tradizione e da essa ci sentiamo confortati per tendere tutte le nostre volontà verso una grande speranza. I tempi si evolvono, le forze e i metodi mutano secondo le esperienze della storia. Come dice bene, signor borgomastro, l’ammaestramento del turbinoso passato, per tutti i popoli europei, è questo: l’avvenire non si costruisce col diritto della forza, nè con lo spirito della conquista, ma con la pazienza del metodo democratico, con lo spirito costruttivo delle intese, nel rispetto delle libertà”.
L’Assemblea comune definita “ad hoc” accettò il mandato conferitole dal Consiglio dei Ministri della CECA e iniziò i propri lavori il 15 settembre dopo avere eletto Paul-Henri Spaak come presidente, venne fissato il termine del 10 marzo 1953 per presentare il progetto di Statuto.
Alla fine dei lavori il testo prevedeva la creazione di una nuova organizzazione di tipo federale che avrebbe assorbito sia la CECA che la CED e strutturata in una Comunità politica competente in materia di politica estera, integrazione economica e sociale, tutela dei diritti dell’uomo. Si prevedeva un Parlamento, composto da una Camera di Deputati eletta a suffragio universale e da un Senato costituito dalle rappresentanze dei Parlamenti nazionali, un Consiglio esecutivo, un Consiglio dei ministri nazionali composto da un rappresentante per ogni Governo ed una Corte di Giustizia.
Enrico Galvan