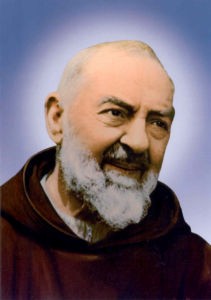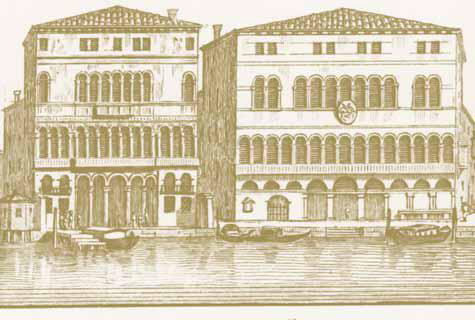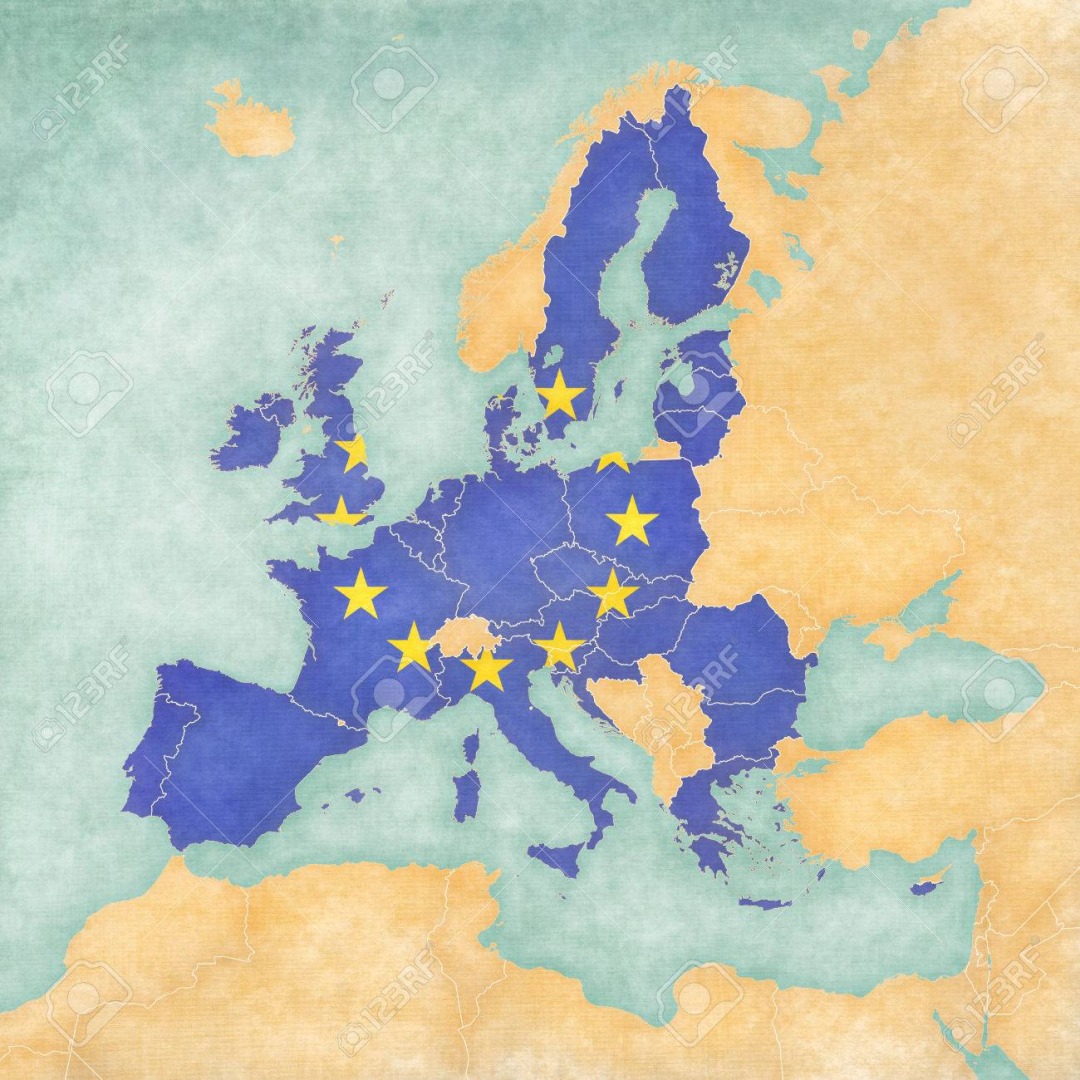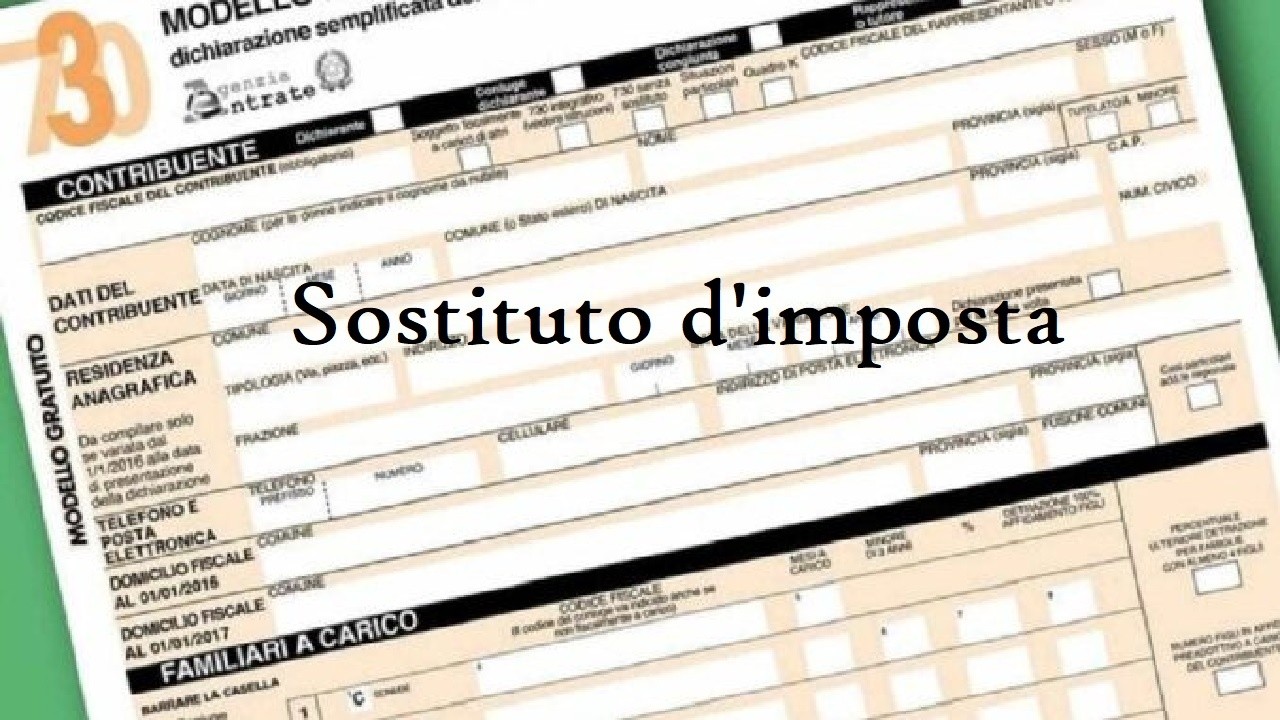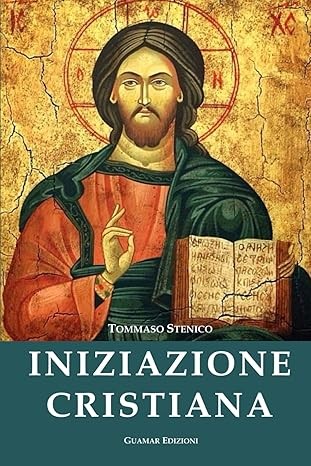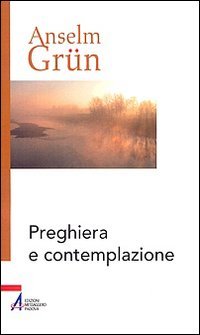di Ruggero Morghen
“Inguaribile battezzatore”. Così Tom Antongini, che fu suo segretario, definiva il poeta Gabriele d’Annunzio per quella sua manìa di modificare nomi, e soprattutto di dare nomi nuovi alle persone che lo interessavano. Innumerevoli furono infatti i nomi dati da d’Annunzio alle sue innumerevoli donne. “Uno dei suoi primissimi, quasi fanciulleschi amori – ricorda ancora Antongini – fu per una contadinella che egli chiamava Splendore; ed era biondissima”, né va dimenticata la Calcinella, “quella che sotto il nome di Lilia, è cantata da lui nel Primo Vere”. Nel 1921, tra l’altro, d’Annunzio darà il nome alla pittrice Novella Parigini, scrivendone alla madre Emilia: “Osservo un pargolo che ruzza sull’erba novella più verde della malachite. Quale nome migliore, appunto, di Novella alla tua pargoletta?”. L’anno prima, a Fiume, aveva inventato dodici nomi di danze, fa sapere Giordano Bruno Guerri.
Un altro, meno riconosciuto, “battezzatore” fu Luciano Rispoli, maestro dell’amico Mariano Sabatini, che a tal riguardo commenta: “Peccato che l'ignoranza dilaghi e stentino a riconoscergli i tanti meriti. La Rai ha allestito uno speciale per ricordare Costanzo e niente per lui... che schifo!” Per Alfredo Bolognesi, che scoprì in un concorso nazionale per giovani talenti indetto dalla Rai, Rispoli ideò infatti (su sua richiesta) il nome d’arte di Alberto Terrani, con cui il Bolognesi si fece conoscere come attore dando poi il volto agli antieroi degli sceneggiati Rai dell’epoca; memorabile fu la sua interpretazione di Uriah Heep nel David Copperfield diretto nel 1965 da Anton Giulio Majano.
Dante Guardamagna, regista e sceneggiatore, diede invece a Raffaella Pelloni il nome d’arte Carrà, che tanta fortuna le avrebbe portato nel campo dello spettacolo (non così a suo fratello Enzo, che pure per un tratto lo assunse) creando una perfetta e armonica sintesi sonora col nome Raffaella. Guardamagna veniva da Fiume, dov’era nato nel 1922, dunque solo due anni dopo l’amara conclusione dell’Impresa dannunziana di Fiume con quel “Natale di sangue” che fu fatale anche al trentino Italo Conci.
Nel 1961 Raffaella, interpretando la principessa Saliurà, recita in un peplum di Antonio Leonviola: “Maciste l’uomo più forte del mondo”, e Maciste è personaggio di fantasia creato dal Vate. Un’altro legame di d’Annunzio colla Carrà, entrambi figli dell’amarissimo Adriatico, venne evidenziato da Fruttero e Lucentini, famosa coppia di scrittori e traduttori. Alla domanda “Ma oggi d’Annunzio andrebbe ospite da Raffaella Carrà?” - erano i tempi gloriosi di Pronto Raffaella?, quando anche i politici famosi facevano a gara per apparirvi - i noti scrittori infatti risposero: “Ma sarebbe lui la Carrà!”, quasi fossero due divi allo specchio. Ed ecco oggi un nuovo spunto venire dalla talentuosa fotografa Marinetta Saglio Zaccaria, che dal baule dei ricordi tira fuori una dedica fattale “con affetto” proprio dalla soubrette di Bellaria, che nel frontespizio del suo libro di ricette la definisce “l’Occhio magico di tanti momenti”.
Il termine mi pare possa ben contenere quasi un richiamo implicito alla figura dell’Orbo veggente, quale si definì lo stesso d’Annunzio dopo l’incidente aereo occorsogli il 16 gennaio 1916 nei pressi di Grado. Significativa, in proposito, appare una sua lettera al capo del governo del gennaio 1933: “Mio caro compagno, dal giorno solenne della tua concisa orazione nel Senato le tombe de’miei morti sul Mastio e la prora della nave Puglia sono coronate di lauro che si rinnova e di quercia che si dissecca. L’Orbo veggente conosce ogni ora propizia a ogni atto temerario”. Perché non mi mandi – senza compromissione del Palazzo Chigi – a tentare la penultima ventura? Lasciami morire”. Come Orbo veggente, peraltro, il poeta s’era già qualificato in una lettera a Mussolini dell’anno precedente, datata 13 settembre: “Io molte cose vedo Orbo veggente; e alcune vorrei mostrarti e illustrarti”.