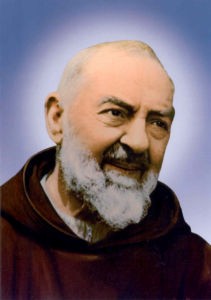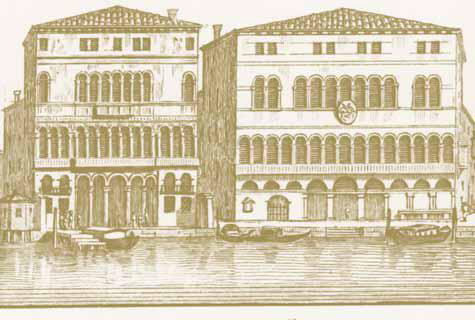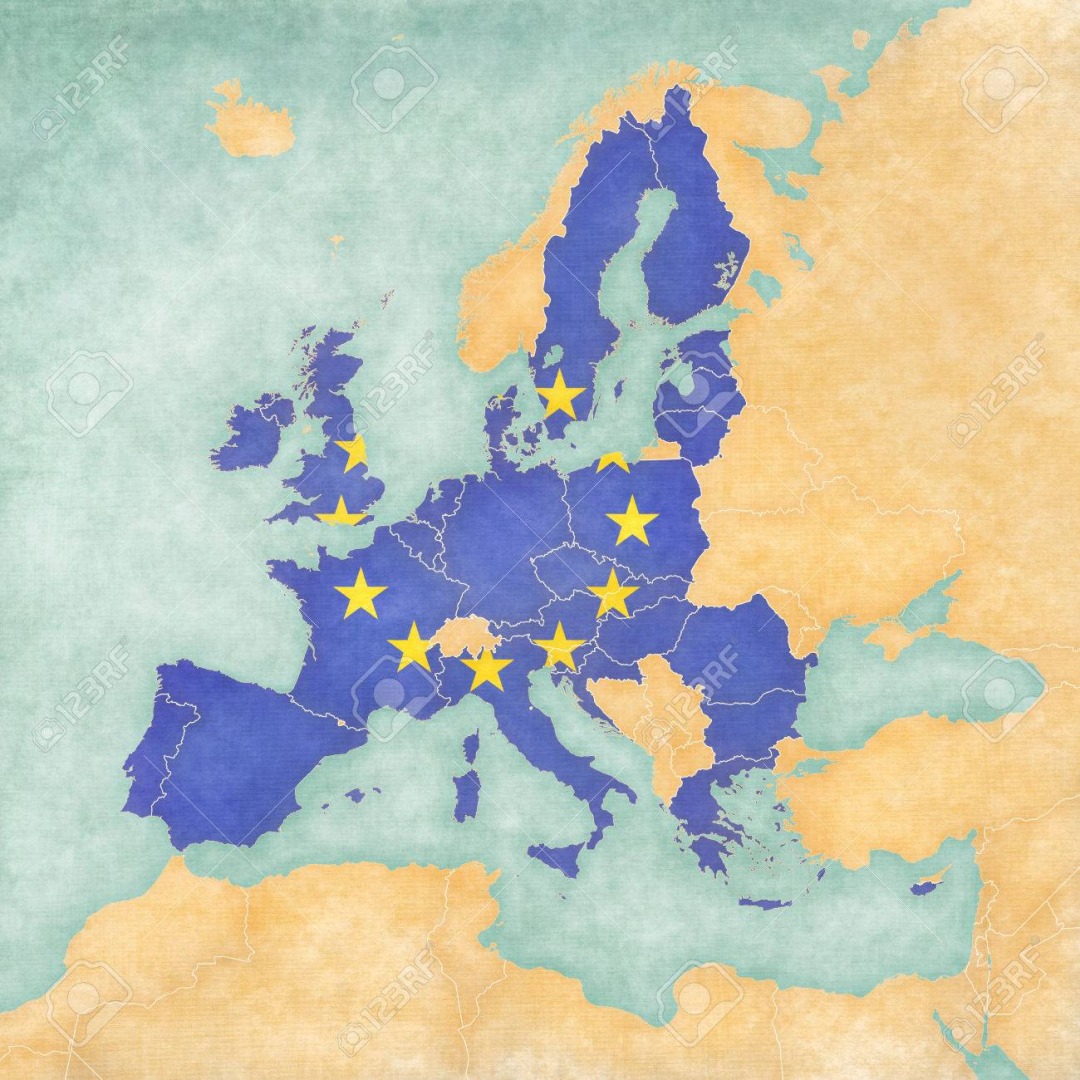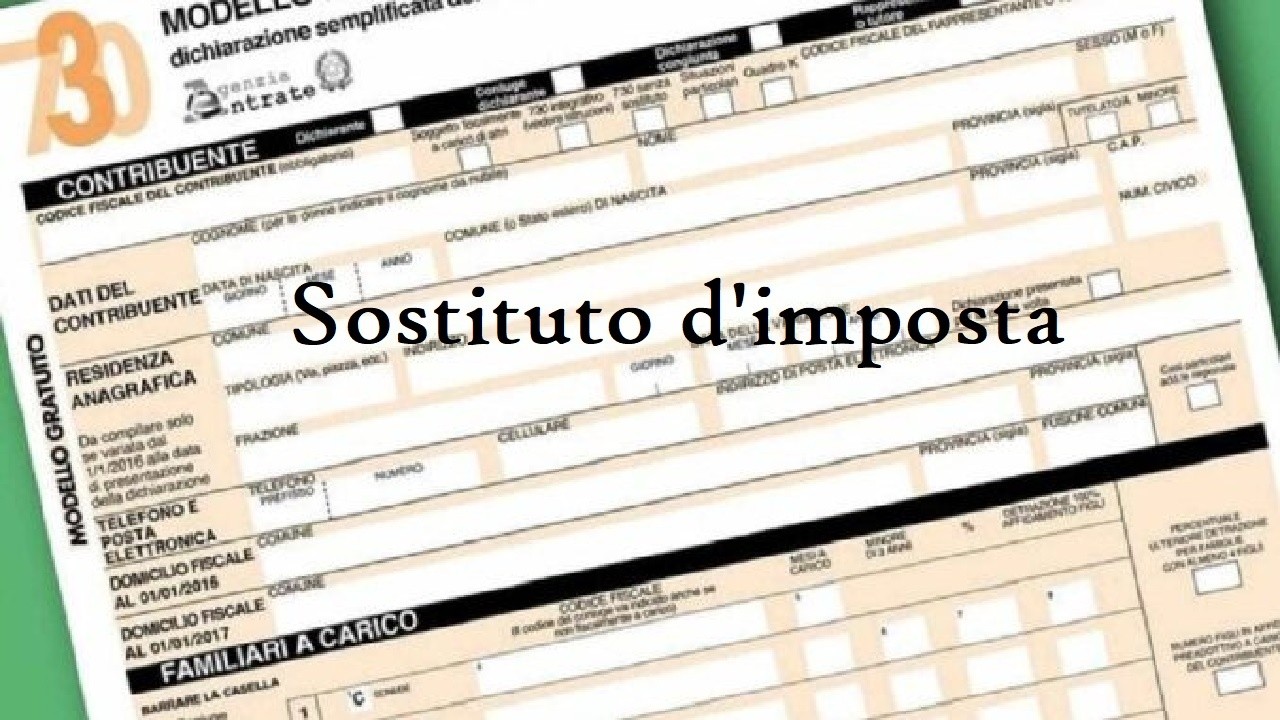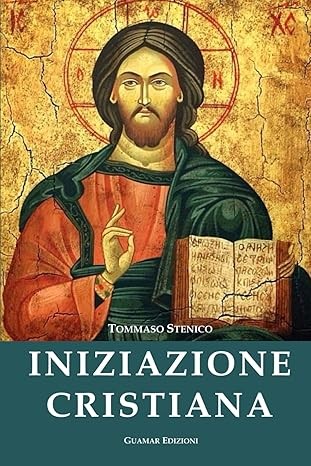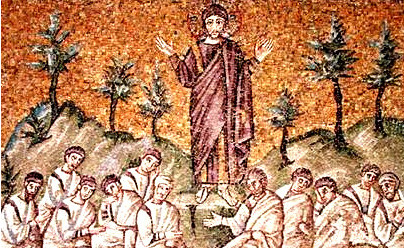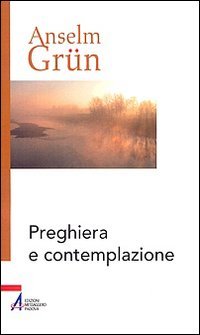di Orizzonte
Vogliamo iniziare questa breve nota con la citazione di un brano apparso nell’editoriale del n. 2/2025 di Aspenia (dal titolo “La fine di un mondo, non del mondo”, pag.5) che dice così:” L’interdipendenza economica non ha prodotto la pace, come riteneva una lunga tradizione di pensiero, da Kant in poi; ha aumentato la vulnerabilità”.
L’espressione, presa in sé e per sé, coglie la realtà in cui siamo immersi; un contesto in cui il vento della cd. moderna globalizzazione (prima di quella attuale ricordiamo che la maggiore fu realizzata dall’impero britannico attraverso le conquiste coloniali, l’espansione commerciale, la rivoluzione industriale, l’introduzione di lingua ed istituti giuridici di common law e l’ internazionalizzazione della sterlina come moneta di riferimento ), dispiegata su matrice statunitense a partire dalla fine della guerra fredda, e fortemente imperniata sul controllo delle vie marittime di accesso ai continenti (premessa indispensabile per proteggere i traffici per mare), ha iniziato a spegnersi per il ritorno al più tradizionale realismo delle relazioni internazionali, imperniato su potere militare, zone di influenza, maggiore autarchia tecnologica, ridefinizione di vecchie alleanze e nascita di nuove, competizione estrema fra gli stati ed interventi pubblici nel mercato per indirizzarlo verso finalità spiccatamente più securitarie.
Chi conosce la storia non rimane, certamente, impressionato da tale nuova piega degli eventi, perché, per millenni, tutto ciò è stato il naturale scorrere degli umani comportamenti delle società sia nella declinazione di imperi o di regni, che in quello di repubbliche o città-stato.
Scriveva già Agostino nel De Civitate Dei (libro IV): “Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia? Quia et latrocinia quid sunt nisi parva regna?” (“se non praticano la giustizia che sono i regni se non bande di ladri di grandi dimensioni? E le bande di ladri, cosa se non piccoli regni?”)
I concetti di sovranità e di Stato nazionale trovano la nascita con la pace di Westphalia che, nel 1648, terminò la Guerra dei trent’anni, iniziata per motivi religiosi, con lo scontro fra cattolici e protestanti, e che si era, ben presto, trasformata in una lotta serrata fra l’impero (esemplificato nell’universalismo aggregante di genti di differente lingua, religione e costumi) e le emergenti aspirazioni degli stati moderni, che desideravano affrancarsi dalla sua potestà.
A Munster ed Osnabruck, sedi della firma dei Trattati di quella Pace, per la prima volta, debutta la nuova forma di Stato e della sua Ragione (già teorizzata dal Machiavelli e dal Botero), che si configura giustificata esclusivamente dal perseguimento dei propri fini, senza più alcuna dipendenza dal potere religioso di qualsivoglia istituzione. Nasce, così, il principio dell’inviolabile potestas statuale sul territorio ed entro i suoi confini, con il suo corollario di uguaglianza fra le nazioni (argomenti su cui, nel 1600, il giurista olandese Ugo Grozio molto si soffermò, fondando la scuola del diritto naturale e principiando il diritto internazionale pubblico nella celebre opera De iure belli ac pacis).
Curiosamente, furono proprio due cardinali di Romana Chiesa, Richelieu e Mazzarino, gli artefici più eminenti di quel disegno basato sull’equilibrio di potenza e che prende il nome di politica realistica o realpolik.
Una forma, potremmo dire oggi, di intendere la sfera del Politico (in prevalenza sul versante dell’estero) come dipendente da parametri squisitamente materialistici (la forza militare e commerciale), con notevole anticipazione temporale rispetto al pensiero del più famoso ideatore di quella teoresi dialettica (il materialismo) in ambito economico e sociale: il filosofo di Treviri Karl Marx.
Gli studiosi di scienza della Politica ritengono quello il momento fondante del nuovo Ordine internazionale che oggi viene, di nuovo, ad essere riproposto come modello da raggiungere, dinanzi alla presa d’atto del fallimento del meccanismo onusiano nel prevenire e gestire i conflitti (sia pure nella declinazione più avanzata di un diritto umanitario, che giustifica un interventismo che costituisce eccezione al più tradizionale principio di non ingerenza negli affari interni di uno Stato di cui all’art.2.7 dello Statuto dell’Onu).
È, cioè, l’equilibrio delle forze che garantisce dall’aggressione altrui (la cd. deterrenza).
Quando questo viene alterato, il sistema piomba nel rischio che qualche attore internazionale sia tentato dall’imporre la propria volontà agli altri, sottomettendoli.
La logica è, forse, brutale, ma ricordiamo che il Seicento è anche il secolo da cui scaturisce la concezione, tuttora attuale, di Stato come soggetto che ha il monopolio della forza ne cives ad arma ruant (affinché i cittadini non vengano alle armi) Il Leviatano di Hobbes forgerà tutta la Teoria statuale dei secoli successivi alla sua pubblicazione (1651).
A questa concezione si ispirano il Congresso di Vienna (1814) e l’accordo di Yalta (1945), che hanno garantito delle paci durature agli europei.
Le varie altre guerre che, dal 1945 al 1990, si sono succedute, in fondo, possono essere considerate come momento di riaffermazione delle aree di influenza sancite nella capitale crimeana.
Ci riferiamo, particolarmente, alla guerra di Corea, a quella del Vietnam e dell’Afghanistan (1979). Ed anche i conflitti armati di decolonizzazione in Indocina, Algeria, Angola, Malesia, Congo e Mozambico, per l’aiuto fornito ai contendenti dalle grandi potenze, possono essere annoverati quali loro appendici.
Con la fine della Guerra fredda e con la caduta del contraltare geopolitico degli Usa, l’Urss, è sembrata avverarsi la profezia del politologo Fukuyama (nel suo “The end of the history and the last man”, Free Press, N.Y., 1992), destinata ad espandersi in tutto il globo, vale a dire il trionfo della liberaldemocrazia e del libero scambio, sotto l’egida dell’unica super potenza rimasta, quella statunitense.
Tuttavia, ben presto, con la grande crisi finanziaria del 2008 (in molta parte dovuta ad una speculazione non adeguatamente vigilata e limitata), le aspettative pacifiche neoliberiste della prima amministrazione Clinton (complice un frettoloso ingresso, nel 2001, della Cina nel WTO, guidato da intento prevalentemente economicistico di riduzione dei costi di produzione e di apertura di un nuovo mercato, ignorando proprio la teoria del bilanciamento delle forze di vestfaliana memoria) si sono, vieppiù, infrante, dinanzi all’uso dell’ economia come mezzo di crescita di potenza di Pechino, prima e di altre potenze emergenti e revisioniste, ora ed hanno innescato ampie insoddisfazioni sociali fra la popolazione nordamericana (privata di posti di lavoro in Usa, spostati in Asia) accrescendo povertà, disuguaglianze ed erosione del ceto medio (in un’ Unione confederale che manca da sempre di un diffuso Stato sociale, che è anche elemento di civiltà e di dignità umana). Aspetti, questi, che si sono riversati negli esiti elettorali ben noti nel nostro continente ed oltre l’Atlantico (per una lettura critica, recente e di parte anglosassone, sul tema, si consiglia il saggio dello storico G. Gerstle, The rise and fall of neoliberal order: America and the World in the free Market Era, Oxford University Press, 2022).
Così essendo i tempi nei quali viviamo, il ruolo dello Stato ritorna ad essere protagonista, come dimostrano le posture assunte dalle maggiori potenze (Usa, Cina, Russia), da quelle in via di forte crescita, con collettività giovani e notevoli ambizioni (Turchia, Arabia, Iran, Brasile, Pakistan, Indonesia), dai Paesi vicini a noi per confini, tradizione, cultura, economia (i membri della UE); e come certificato anche dall’ impossibilità di adottare decisioni all’unanimità fra i membri della Unione Europea in materia militare e di politica estera.
Il che, ovviamente, apre, però, la strada ad alleanze e trattati trasversali con altri partners europei con cui si registrano convergenze di ampio orizzonte.
Certamente non può essere sottaciuta l’incidenza dei conglomerati economico-tecnologici, i cui proprietari esercitano un peso cruciale nell’economia ed anche nella politica dell’Occidente, ma pensiamo che, comunque, per quanto essi dispongano di influenza, questa sarà preferibilmente dispiegata attraverso le istituzioni politiche cui afferiscono, più che in modo autonomo rispetto ad esse.
A tutt’oggi, infatti, non esiste un’alternativa più resistente e razionalmente giustificabile, anche in termini di consenso democratico, di quella espressa dal concetto vestfaliano di Stato, che ha costituito il fine del romanticismo, l’espressione del binomio popolo-istituzioni, l’ingresso delle masse nel governo della Res Publica, l’inveramento della volontà generale ideata da Rousseau.