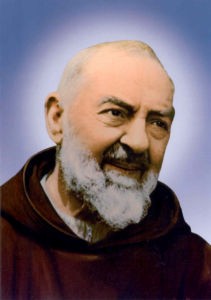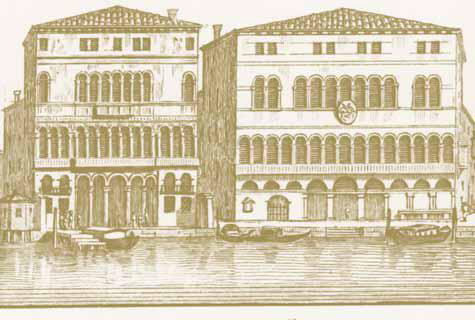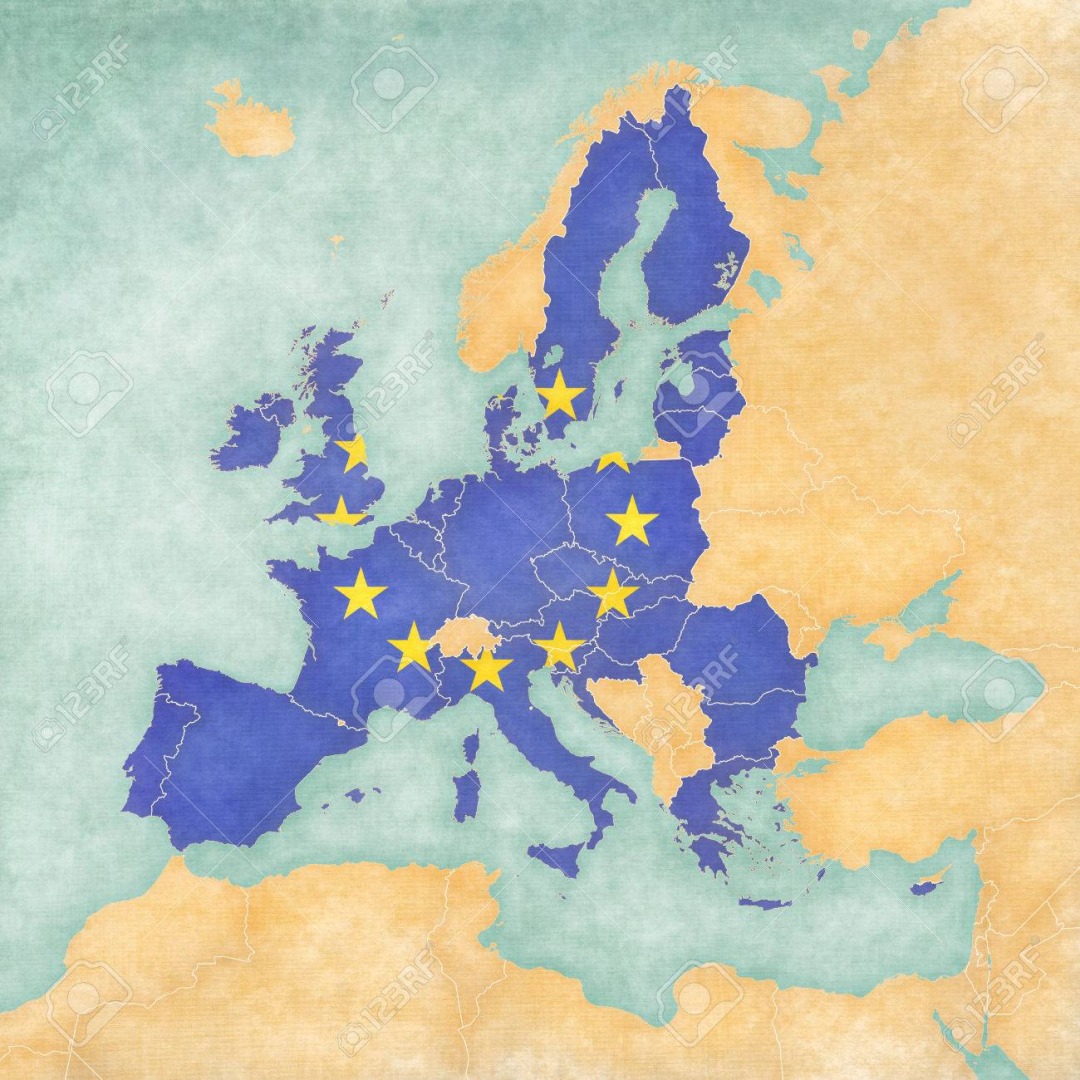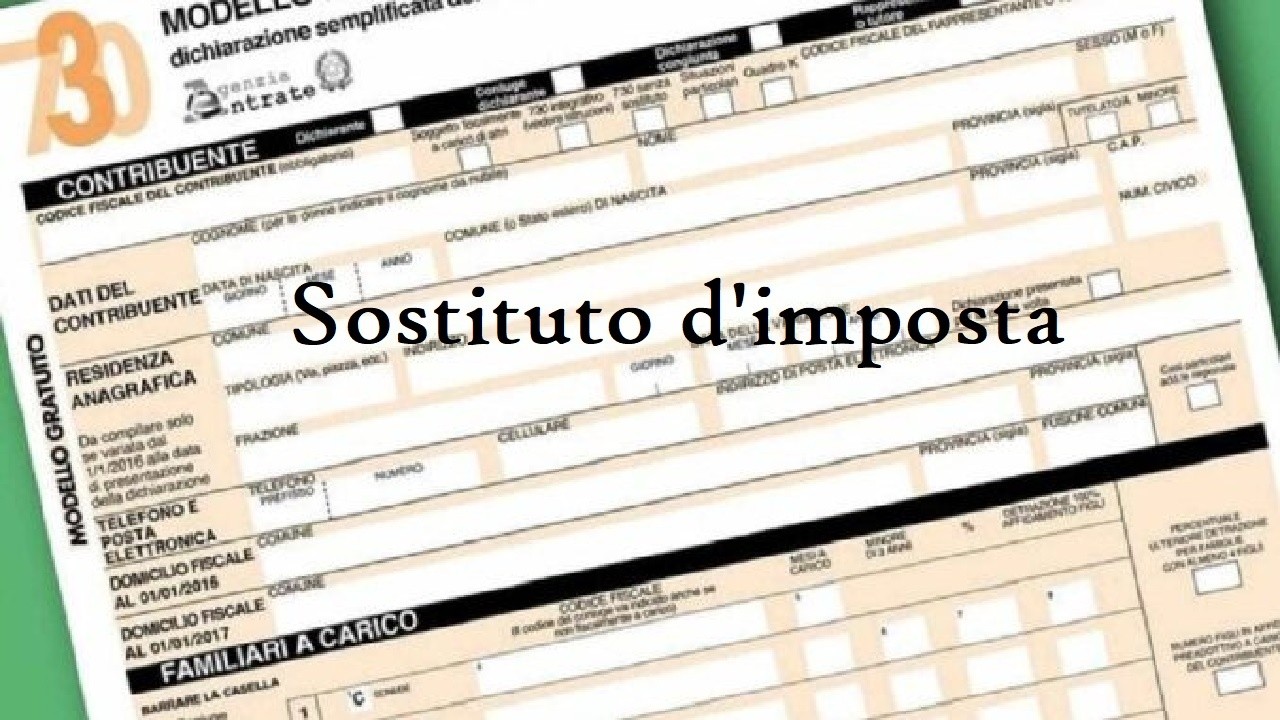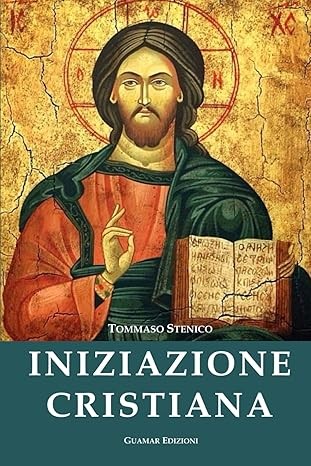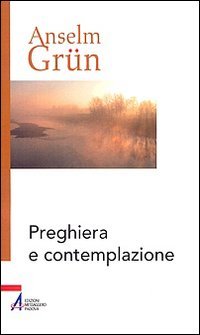di Ruggero Morghen
Ad Arco di Trento si torna a parlare dell’avvocato Scipio Sighele. Elena Bovo, autrice di “Pensiero della folla, pensiero dell’inconscio”, si propone infatti di ridare oggi a Sighele – a livello non solo italiano, ma internazionale – il posto che gli sarebbe stato rubato. A tal riguardo ricorda che in Francia Sighele, di cui lei particolarmente apprezza l’idea di un’imitazione anche orizzontale (quindi “senza la necessità di un capo”) nel fenomeno della folla, era fino a poco tempo fa un perfetto sconosciuto (“adesso un po’ meno”), essendo stato letteralmente plagiato da Gustave Le Bon.
A Sighele psicologo, sociologo e criminologo che in “Contro il parlamentarismo” (1895) applica al parlamento gli strumenti della psicologia collettiva di cui fu pioniere, si deve in effetti un’analisi sistematica della psicologia delle masse (per lui, come per Tarde e Le Bon, la folla è donna). Lo rileva Michela Nacci: egli vedeva la sociologia come “una riproduzione” della psicologia, “fedele nelle sue grandi linee, ma immensamente più complessa e vasta”: si potrebbe dire “una psicologia in grande”.
Ecco Sighele a Rovereto, Palazzo della pubblica istruzione, anno 1896. Invitato dalla Società degli studenti trentini, che l’ha voluto a chiudere un ciclo di conferenze, l’avvocato Sighele parla di delitti e delinquenti danteschi. “Facendo violenza alla mia doverosa modestia – confessa – ho risposto all’invito da buon positivista: venendo”. Quindi analizza le figure di alcuni delinquenti, create da romanzieri e poeti “non colla paziente precisione dello scienziato – osserva – ma colla felice intuizione dell’artista”. In tale ricerca si distinguono i romanzi di Gabriele d’Annunzio, che “con delle esagerazioni patologiche dipingono i delinquenti furbi e vili di quest’epoca fiacca e vigliacca”. In conclusione Sighele rivolge un pensiero anche a Rosmini gloria roveretana: è lui “il filosofo cattolico più illustre”, lui “il prete più santo di questo secolo”.
In veste di avvocato, il 5 marzo dello stesso anno Sighele telegrafa ad Oreste Baratieri da Roma offrendosi di assumerne la difesa dopo la disfatta di Adua. “Come italiano e come trentino – gli scrisse infatti a Massaua, dove il generale in stato di detenzione era agli arresti domiciliari nel palazzo del governatore -, nell’ora della sventura, vi offro la mia modesta opera di difensore”. Ma non fu possibile accettare l’offerta poiché in un tribunale militare un avvocato civile non poteva assicurare il patrocinio. Quando il compianto Ferdinando Martinelli scrive che Sighele, avvocato difensore nei processi per gravi reati, “fu difensore del generale Oreste Baratieri per la sconfitta di Adua”, non lo intende evidentemente in senso tecnico-giuridico.
Contestualmente al suo messaggio telegrafico Sighele rese nota all’opinione pubblica la sua posizione nei confronti del generale sotto accusa, “un valoroso – così lo definiva - il quale non ha mai sfuggito il pericolo, ma lo ha sempre cercato”. Un uomo inoltre – scriveva il 17 marzo dalle colonne dell’Alto Adige – “presso il quale non mi sono mai fatto vivo mentre l’Italia tutta con esagerazione nevrotica lo salutava conquistatore”. Tutti coloro, però, che “lo hanno colmato di elogi, di banchetti, di onori, adesso lo denigrano! E mi fanno schifo”. L’avvocato confessava quindi di ritenere della disfatta di Adua, tra Baratieri e il governo, più colpevole quest’ultimo. Verso Baratieri nutriva piuttosto sentimenti di pietà, anche se – riconosceva – “è molto colpevole”. “Fin che egli – aggiungeva Sighele – rimane nell’ora triste del dubbio e dell’accusa, quest’amicizia verso di lui deve farsi più forte, perché è nella sventura che gli affetti si provano”.