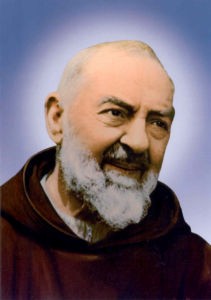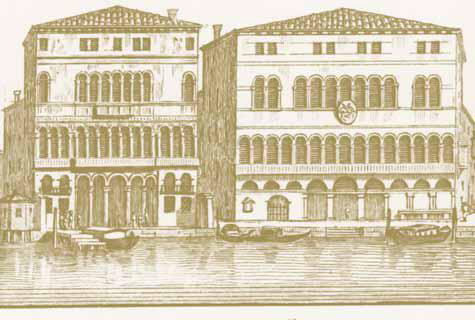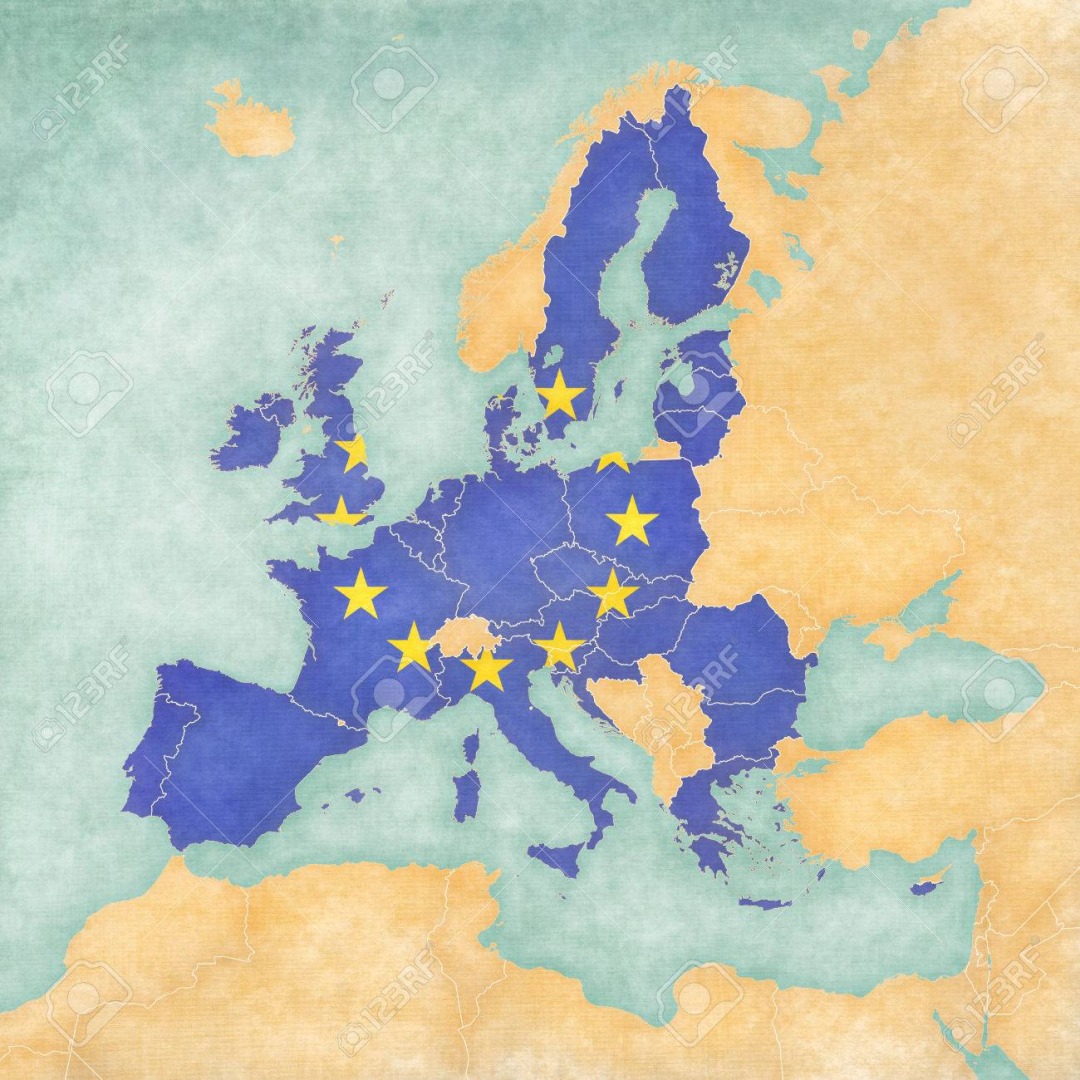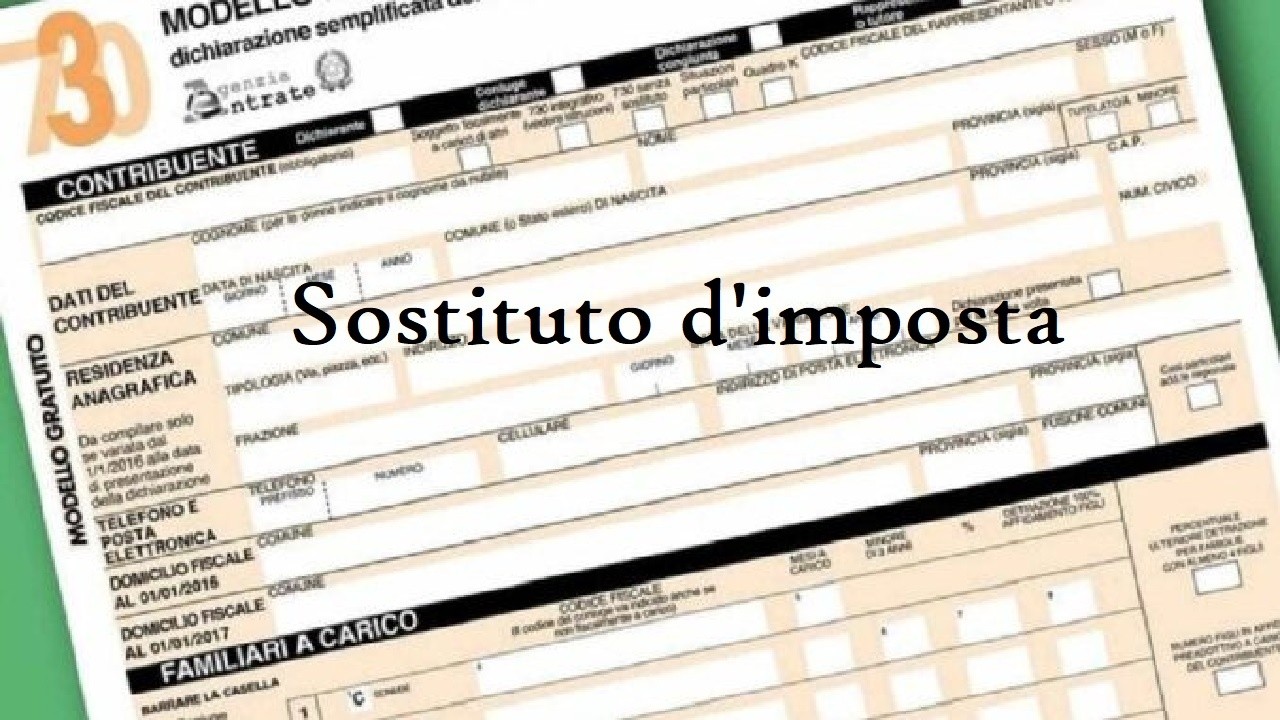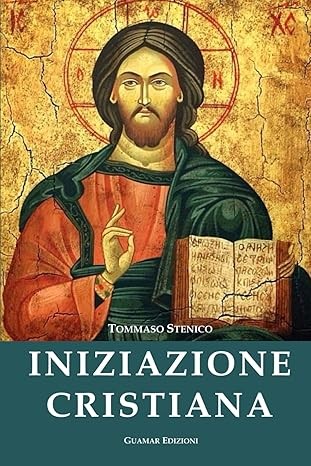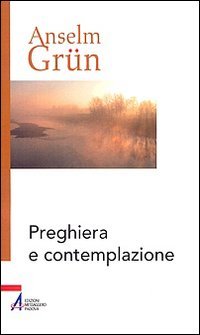di Orizzonte
In queste ultime settimane sono accaduti eventi di significativo peso nelle relazioni internazionali. Infatti, se, da un lato, si sta consumando uno scontro commerciale duro ed inedito fra Usa ed UE sull’applicazione dei dazi reciproci, in una cornice che non si esaurisce all’aspetto delle importazioni ed esportazioni, ma investe anche normative europee di primaria importanza per i colossi americani del digitale come il “Digital Markets Act” ed il “Digital services Act” (si vedano le sanzioni pecuniarie inflitte ad Apple e Meta dalla Commissione Europea in Apple and Meta to be hit with first DMA fines, www.axios.com, 22/04/2025; ed anche Commission finds Apple and Meta in breach of the Digital Markets Act, www.europa.eu , 23/04/2025), dall’altro, nuovi accordi politico militari si sono firmati fra Regno Unito, Polonia, Francia e Germania, per creare un primo nocciolo di Difesa militare strutturata fra stati europei, al di fuori del Trattato sull’Unione Europea (TUE) ed al di fuori della Nato.
Ricordiamo che l’art. 24 del TUE stabilisce l’obiettivo di addivenire ad una “definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune”.
La politica estera e di sicurezza comune è delineata ed attuata dal Consiglio europeo (che riunisce i capi di Stato o di Governo dei membri) e dal Consiglio che deliberano all’unanimità, salvo i casi in cui i trattati dicano diversamente. Essa è realizzata dall’alto rappresentante della UE per gli affari esteri e la sicurezza (attualmente l’estone Kaja Kallas).
Gli stati membri, in questo quadro, devono astenersi (art.24.5 del TUE) da qualsiasi azione contraria agli interessi dell’Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali (tale potrebbe essere, ad esempio, trattare sui dazi separatamente. Stupisce che nessuno mai lo ricordi in televisione o sui giornali).
Spetta al consiglio Europeo definire gli interessi strategici dell’Unione (art.26 del TUE), nonché elaborare la politica estera.
Attualmente l’art.42 del TUE prevede la creazione di una capacità operativa militare della UE, lasciata, però, alla volontarietà di contribuirvi da parte dei singoli Paesi europei.
Qualcosa, quindi, di molto meno organizzato della struttura militare della Nato o di eventuali patti bi o plurilaterali fra Stati, come da sempre si è fatto in Politica estera.
La difesa comune (così è scritto all’art.42.2 del TUE) sarà attuata quando il Consiglio europeo lo deciderà con decisione presa all’ unanimità.
Il nodo della unanimità, come evidente, appare oggi difficilmente sormontabile, dal momento che ciascuno Stato membro ha una propria politica estera di cui molto difficilmente (specialmente se di passata tradizione di potenza e con interessi differenziati dalla collocazione geografica, dal potenziale industriale, dalle proprie zone di interesse esclusivo) vuole spogliarsi, poiché, spesso, parte anche della propria pedagogia sociale e memoria storica. Senza contare che oggi la disponibilità di una forza nucleare militare proietta lo Stato che ne dispone ad un livello di importanza certo superiore a quello degli altri che ne sono privi.
È, però, pur vero che l’art. 42.7 del TUE prevede che, qualora uno stato europeo subisse un’aggressione armata al proprio territorio, gli altri “sono tenuti a prestargli aiuto ed assistenza con tutti i mezzi in loro possesso in conformità dell’art.51 della Carta dell’Onu”.
In modo esplicito questa norma impone l’intervento armato di tutti a supporto di qualunque paese della UE che fosse attaccato nel suo territorio, con ciò confermando il diritto naturale all’autodifesa dichiarato dallo Statuto delle Nazioni Unite.
Una disposizione speculare al famoso art.5 del Trattato della Nato, in una formulazione, forse, ancora più stringente.
Potremmo, quindi, sostenere che, se un esercito europeo comune dipende dalla decisione unanime del Consiglio europeo, l’intervento difensivo nazionale è un obbligo che ciascuno stato della UE deve osservare, già adesso, nel caso di attacco ad un altro stato dell’Unione.
Tuttavia, ciò che si è materializzato nelle ultime settimane rappresenta un passo ancora più avanti rispetto all’ architettura sopra delineata.
Il 9 luglio scorso Regno Unito e Francia, inserendosi nel solco sperimentato della “entente cordiale”( siglata dai due ex imperi nel 1904 per porre fine alle dispute e realizzare una migliore suddivisione della propria area di influenza), poi sfociata nell’alleanza militare durante la prima e la seconda guerra mondiale, e negli accordi di Lancaster House del 2010 (che hanno gettato le premesse per una cooperazione militare di ampio raggio, includendo la creazione di un corpo franco britannico di 10.000 soldati schierabile, con poco preavviso, in zona di combattimento, nonché per la condivisione di informazioni e la realizzazione di sistemi d’arma comuni a livello industriale e tecnologico), hanno firmato la dichiarazione di Northwood (sede della base militare teatro della sottoscrizione dell’accordo).
Con questo nuovo patto le due uniche potenze nucleari europee hanno deciso di coordinare, per la prima volta, l’impiego delle reciproche forze missilistiche atomiche attraverso la creazione di un organismo congiunto, separato sia dalla Nato, che dalla UE, che andrà a costituire un ombrello di difesa anche per gli altri stati europei che lo vorranno.
Pur mantenendo gelosamente la gestione sovrana dell’uso dell’arma nucleare, le due nazioni hanno affermato di avvertire una “speciale responsabilità” verso la sicurezza del Continente, specialmente alla luce degli eventi di notevolissimo cambiamento, come la sfida della Russia, l’ambizione della Cina e di altri Paesi che si affacciano, talora con spirito revisionista, rispetto al vecchio ordine posto nel 1991, che superava già quello di Yalta (pensiamo alla Turchia, dedita ad estendere il proprio raggio di azione sul Mar Nero, ma anche nell’Egeo greco, in Siria, verso il Mediterraneo centrale libico e nell’Adriatico; nonché all’India, all’Arabia Saudita ed al Brasile) (Macron pitches Starmer on new special relationship as leaders strike defense deals, in www.politico.eu, 9/7/2025).
L’accordo include anche una forte cooperazione nell’industria militare.
È un cambio del paradigma strategico europeo perché, da questo momento, un attacco non solo a Francia e Regno Unito, ma anche ad altri Paesi che decidessero di accogliere (a quali condizioni non si sa ancora) l’offerta di Londra e Parigi, implicherebbe un possibile contrattacco atomico franco britannico (e ciò indipendentemente dalla reazione della Nato a guida americana).
La portata di questa inedita iniziativa si inscrive nel rientro, a pieno regime, del Regno Unito negli assetti politico militari di equilibrio del continente europeo (necessitati anche dalla postura più lontana assunta dagli Usa) e nell’attività di giocatore di peso di Parigi, attore cruciale sia verso le frontiere esterne dell’Unione (pensiamo alla Russia, ma anche alla Turchia, nella contesa con la Grecia- The France-Greece partnership beyond the Eastern Mediterranean, Schmid, Dos Santos, 2022, in www.ifri.org), che verso un bilanciamento infracontinentale con Mosca e Berlino (con cui esiste dal 1963 il Trattato di amicizia franco tedesco, nato per riequilibrare l’egemonia statunitense sul Continente europeo).
Su quest’ultima notazione non possiamo esimerci dal ricordare che, nel maggio di quest’anno, Francia e Polonia hanno firmato un accordo militare di assistenza e di difesa reciproca (Il Trattato di Nancy), che impegna le due nazioni a prestarsi aiuto militare in caso di attacco (a Varsavia preoccupa, ovviamente, il proprio confine Est, ma, forse, anche certe pulsioni revansciste verso aree dell’ex Prussia orientale trasferite alla sovranità polacca con Yalta).
Ebbene, a seguire, proprio con riferimento alla Germania, è accaduto un fatto altrettanto storico, sempre questo mese.
Germania e Regno Unito hanno concluso il Trattato di Kensington. Primo accordo bilaterale fra i due Stati dal 1945, anno in cui terminò la seconda guerra mondiale con una Germania sconfitta.
Anche in questo caso i due Paesi si obbligano ad aiutarsi in caso di aggressione militare e stringono programmi di sviluppo di sistemi d’arma strategici comuni (Merz calls for UK, Germany and France to align on migration and defence, in www.theguardian.com 17/7/2025).
Questo trattato avrebbe diversi obiettivi: sancirebbe in modo chiaro il posizionamento tedesco rispetto alla Russia e, allo stesso tempo, aggiungerebbe alla difesa della Germania da parte della Nato anche la difesa atomica britannica (sarebbe una rinuncia definitiva ad un proprio potenziale nucleare?).
Come, però, non vedere, in retropensiero, anche una certa precauzione franco inglese rispetto al forte riarmo germanico che potrebbe trovare, in maggioranze politiche diverse dalle attuali, differenti alleanze future.
Insomma, senza attendere il futuribile “esercito comune europeo”, che resta nei sogni di molti, ma non nei cassetti dei decisori più realisti, preso atto del nuovo orientamento degli Usa, i Governi europei dei tre principali Paesi (Regno Unito, Francia e Germania), con l’aggiunta dell’intraprendente Polonia, hanno già stretto accordi per cautelarsi e rafforzarsi nella difesa militare e nella tecnologia di punta e, in questa fitta rete di nuovi patti militari ed industriali (che tradisce una certa diffidenza verso l’efficacia degli attuali accordi UE e Nato), si va delineando un “nocciolo duro” geopolitico continentale (una sorta di direttorio fra decisori di peso), con interessi comuni, al quale altri Stati potranno aderire.
L’Italia ha siglato, nel 2021, con la Francia il Trattato del Quirinale, che contiene anche aspetti di sicurezza e difesa.
La geografia ci vede necessariamente proiettati nel Mediterraneo a tutto campo, ma anche oltre Suez, verso il Mar Rosso e le rotte commerciali verso l’Asia (corridoio India-Medio Oriente-Europa), nonché verso l’area di Libia, Tunisia, Algeria, Egitto e l’Africa interna per sviluppare commerci, partenariati politici e tecnologici, fonti di energia, ricerca di minerali rari e per acquisire profondità strategica difensiva rispetto alle nostre coste (evitando l’insediamento di minacce al territorio italiano).
Da soli, non abbiamo la forza per sostenere questo sforzo ormai dettato dalla realtà degli attori in movimento, ma, con il supporto degli altri Paesi europei maggiori (negoziandone con loro i diversi interessi), siamo in grado di farlo.
Sarebbe questo il momento più propizio e, come gli eventi storici ci suggeriscono, chi entra nel gruppo di testa per primo, poi gode di un vantaggio protratto negli anni a venire.