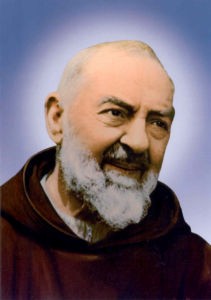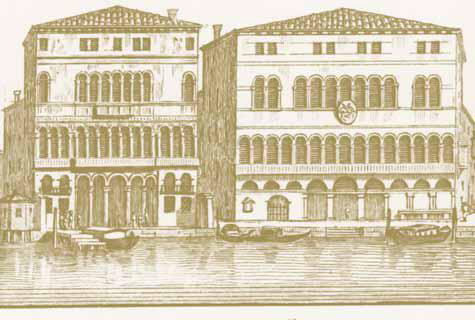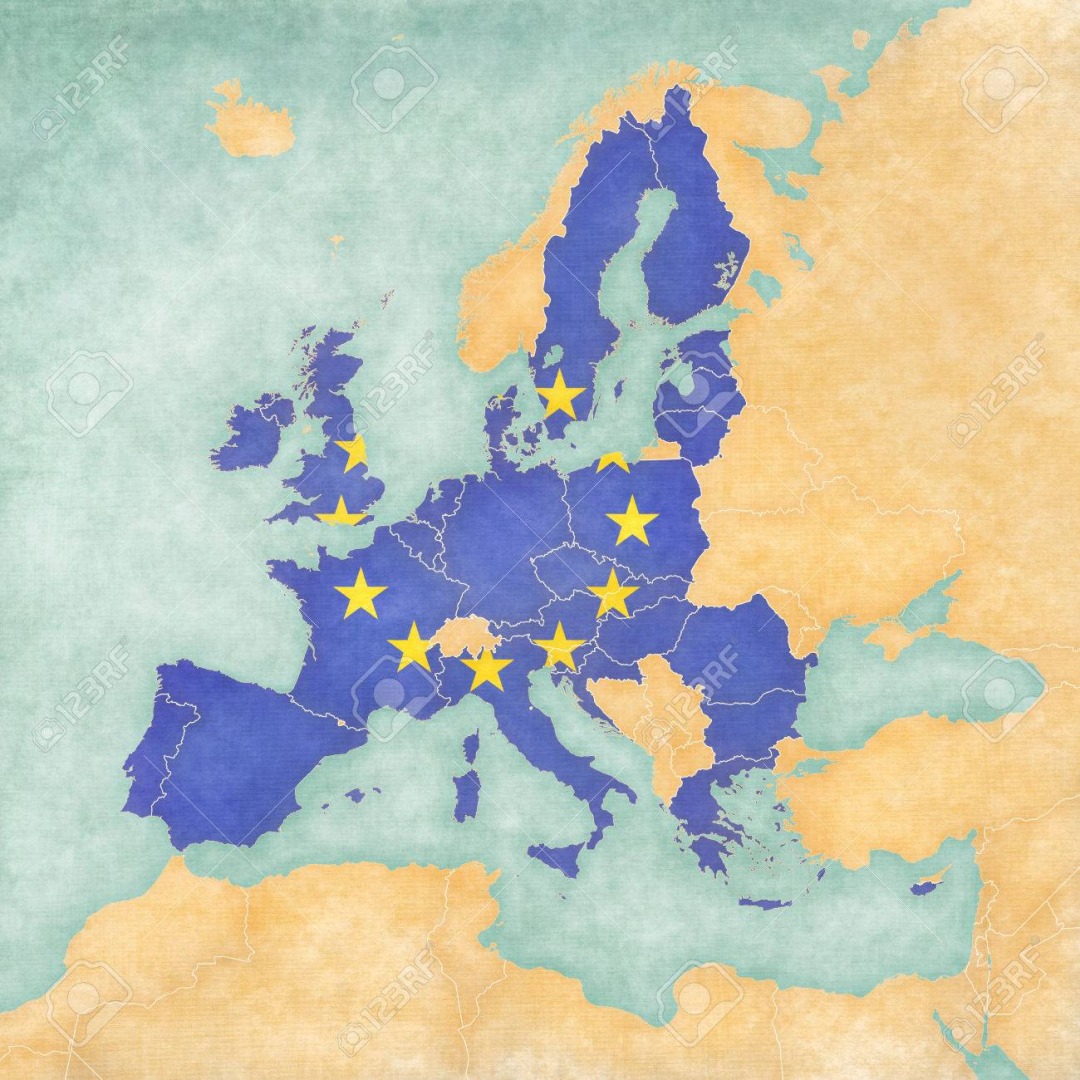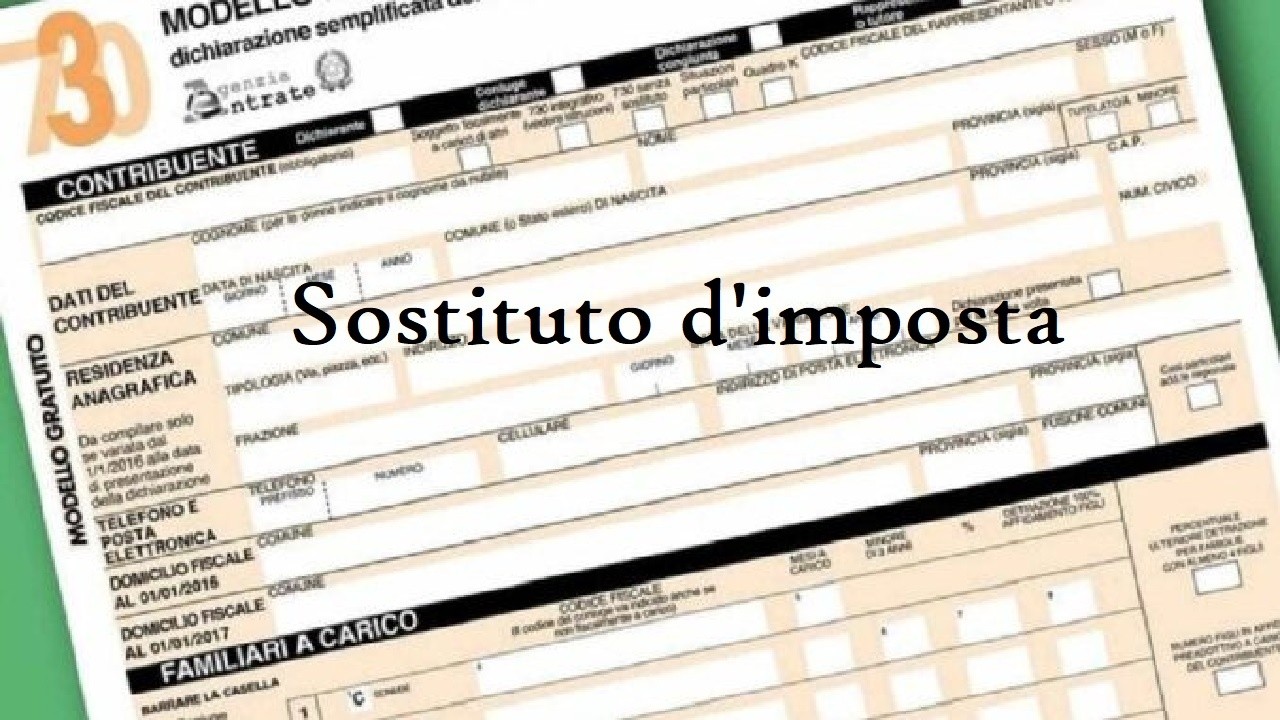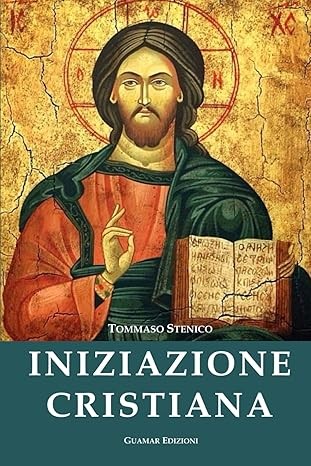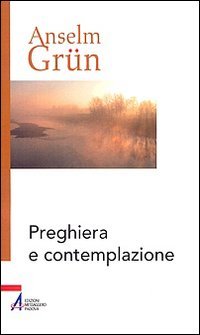di Vittorio Dalbagno
L’organizzazione della giurisdizione oggi
Il sistema attualmente in vigore prevede l’esistenza di un unico Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). La Carta lo concepisce come un organo costituzionale vero e proprio, al quale sono affidati il reclutamento dei magistrati e lo sviluppo effettivo del loro status giuridico e lavorativo.
Esso è formato dal Presidente della Repubblica, che lo presiede (i.e. ne dirige i lavori), dal Presidente, dal Procuratore Generale della Corte di cassazione e da altri 30 membri elettivi che non possono rimanere in carica più di 4 anni e non possono essere immediatamente rieletti.
Dei 30 membri elettivi, 10 sono eletti dal parlamento in seduta comune con maggioranza dei 3/5 dell’assemblea (e ciò per garantire la non riconducibilità ad una parte politica degli eletti) tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati con almeno 15 anni di servizio e 20 sono eletti dai magistrati ordinari.
La Costituzione prescrive quindi un organo a composizione mista, volendo sì che il fulcro sia animato dal corpo degli stessi giudici ordinari (maggioranza di 20 su 30) per garantirne l’autonomia e l’indipendenza, ma che allo stesso tempo non si istituisca come luogo autoreferenziale, cioè come luogo istituzionale in cui i magistrati vengano governati integralmente da loro stessi.
L’elezione dei membri togati avviene attraverso la formazione di collegi elettorali territoriali e nazionali dai quali emergono i 20 magistrati eletti nel CSM. I seggi elettorali sono costituiti presso le sedi di Tribunale e ciascun elettore (l’elettorato è costituito da tutti i magistrati, tranne quelli sospesi o che stanno completando la formazione) può votare nel seggio del Tribunale del luogo in cui ha sede il suo ufficio.
Per quanto riguarda la regolamentazione della carriera dei magistrati, essa ha subito varie modificazioni nel corso degli anni. L’ultima entrata in vigore era compresa nella Riforma Cartabia del 2022 che riduce il numero possibile di passaggi dalla funzione requirente (pubblico ministero) a quella giudicante (giudice) da quattro ad uno soltanto entro 10 anni dalla prima assegnazione. La situazione attuale prevede un percorso unico per la carriera dei magistrati distinti solo nelle funzioni, che essi ovviamente non possono esprimere contemporaneamente: ad esempio ricoprendo in alcuni casi il ruolo di giudice terzo e imparziale e in altri quello di funzionario della pubblica accusa.
L’unico CSM al momento esistente si occupa dell’adozione di sanzioni disciplinari e dello svolgimento altre attività amministrative quali la formazione delle tabelle attinenti la composizione dell’organico dei singoli uffici giudiziari e le valutazioni di professionalità, sia nei riguardi dei giudici che dei pubblici ministeri.
Il nuovo assetto della giurisdizione
La riforma intende modificare il testo degli articoli 87,102,104,105,106,107 e 110 della Costituzione, rispettivamente al fine di:
- assegnare la presidenza dei due nuovi CSM al Presidente della Repubblica;
- predisporre e legittimare l’istituzione di un'Alta Corte alla quale sia assegnata in via esclusiva la facoltà di adottare sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati (togliendo loro la possibilità di giudicarsi in seno ai CSM);
- separare definitivamente la carriera dei magistrati giudicanti da quella dei magistrati requirenti (senza più, quindi, la possibilità di transitare dalla carriera di pubblico ministero a quella di giudice e viceversa), istituendo un CSM specifico per ciascuno dei due tipi di magistratura e definendone le modalità di composizione, prevedendo la partecipazione di diritto del Primo Presidente della Corte di cassazione al CSM giudicante e del Procuratore Generale della Corte di cassazione al CSM requirente. Gli altri componenti saranno estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio della professione, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. I componenti sorteggiati rimarranno in carica quattro anni senza la possibilità di essere nuovamente estratti;
- indicare le attività amministrative (assunzioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità, ecc. dei magistrati) proprie di ciascuno dei due nuovi CSM;
- istituire e definire la composizione dell’Alta Corte che assumerà, lei sola, la responsabilità della giurisdizione disciplinare dei magistrati. Essa sarà composta da: tre giudici nominati dal Presidente della Repubblica, tre giudici estratti a sorte da una lista compilata dal Parlamento in seduta Comune, tre magistrati requirenti e tre giudicanti. Tutti - giudici e magistrati - sono candidabili esclusivamente nel caso in cui soddisfino particolari requisiti previsti dalla legge costituzionale;
- specificare che saranno ammessi al ruolo di consiglieri di Cassazione, su designazione del CSM giudicante, anche magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni;
- rimaneggiare lievemente il testo costituzionale affinché sia adatto al nuovo sistema introdotto;
- indicare il termine entro il quale le leggi relative al Consiglio superiore della magistratura, all’ordinamento giudiziario e alla giurisdizione disciplinare devono essere adeguate alle disposizioni della nuova legge costituzionale.
Ragionevoli aspettative
La riforma contiene importantissime novità con le quali il Ministro della Giustizia intende riportare il nostro Paese alla pari delle altre grandi democrazie europee. In particolare ci si aspetta che, impedendo al magistrato requirente di diventare giudice, si imponga un'ulteriore garanzia a tutela del giusto processo, evitando che chi “fino al giorno prima” era un accusatore di professione - il pubblico ministero - passi al ruolo di “giudicante”, ruolo che, per natura, deve essere incarnato da una figura equidistante da entrambi gli attori del contraddittorio processuale.
I detrattori della riforma oppongono a questa ambizione una argomentazione che si fonda sulla scarsità dei magistrati che scelgono di cambiare carriera (45 su 2517 magistrati assunti tra il 2005 e il 2017 - fonte dati: CSM). Tuttavia, rileva evidenziare il fatto che anche un solo giudice in più diventa un’autorità capace di esprimere un giudizio definitivo nei casi di giustizia quotidiana che investono tutti i cittadini. Risulta, quindi, nel nostro massimo interesse che la figura posta a garanzia del bilanciamento dei diritti incarni col massimo della qualità lo spirito di imparzialità ed equidistanza tra le parti del processo, tenendo dunque conto anche della sua formazione e provenienza professionale.
Inoltre è da notare che, ad oggi, pubblico ministero e giudice, al di fuori dell’aula di Tribunale, svolgono vita comune, ritrovandosi all’interno della stessa associazione professionale (l’Associazione Nazionale Magistrati) e prendendo parte ad eventi collegiali che li riguardano da vicino come, ad esempio, l’elezione dei membri dell’unico CSM che li ricomprende comunemente.
Altra novità importante è la scelta del sorteggio per la composizione di entrambi i nuovi CSM. L’elezione dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura ad oggi in vigore è svolta mediante un meccanismo che conduce alla sua "politicizzazione”, creandosi così l'occasione che lo svolgimento delle importanti funzioni amministrative dell’organo sia condizionato dall’adesione o meno dei destinatari di quegli incarichi alle correnti di volta in volta determinanti. Tale elezione, infatti, si svolge con la presentazione della candidatura esclusivamente personale del magistrato entro 20 giorni dalla convocazione delle elezioni. Risulta quindi probabile che il magistrato che ambisca alla nomina di membro del CSM parli con i suoi colleghi perché questi si convincano delle sue particolari virtù da futuro componente del Consiglio e le ricordino nel segreto dell’urna, affinché l’eletto mostri loro riconoscenza in un eventuale momento di necessità.
Infine, l’ultima novità di rilievo è l’istituzione dell’Alta Corte composta con le modalità sopra esposte. Essa sarà l’unico organo al quale verrà demandata la responsabilità della giurisdizione disciplinare dei magistrati, che, al momento, appartiene al CSM. Oggi ci si ritrova nella condizione in cui membri eletti del Consiglio Superiore della Magistratura debbano giudicare il comportamento dei loro colleghi elettori, magari pure compagni di corrente. A quel punto sarà possibile manifestare qualche dubbio sulla correttezza e imparzialità del giudizio disciplinare che verrà eventualmente pronunciato.