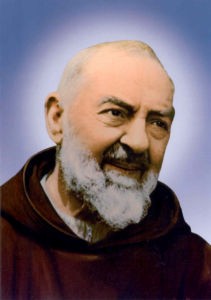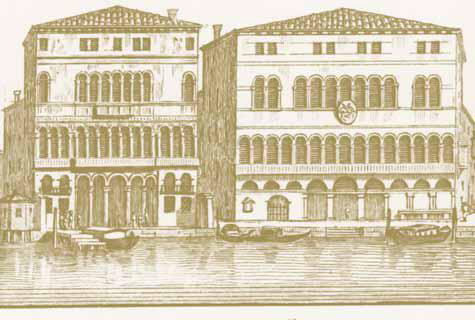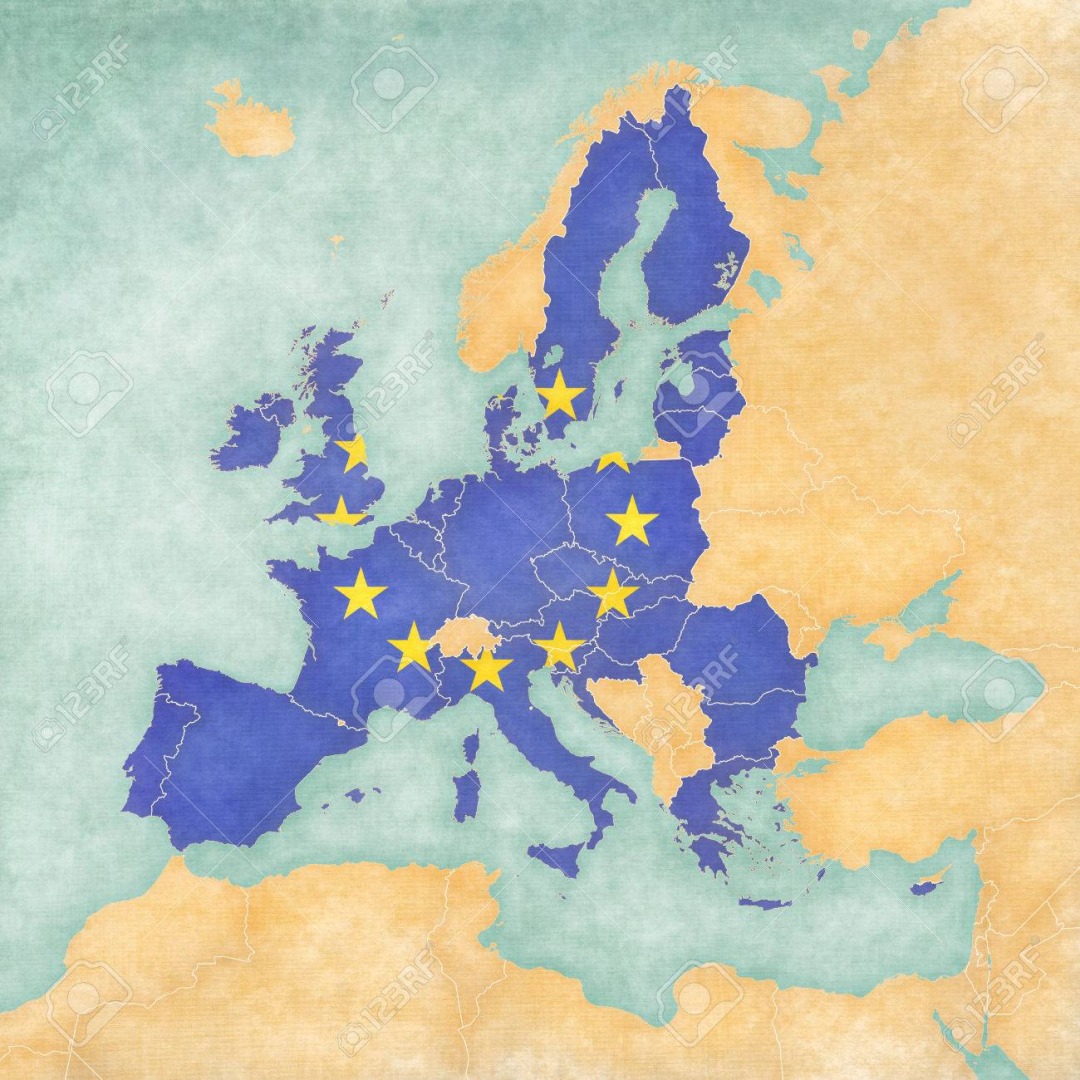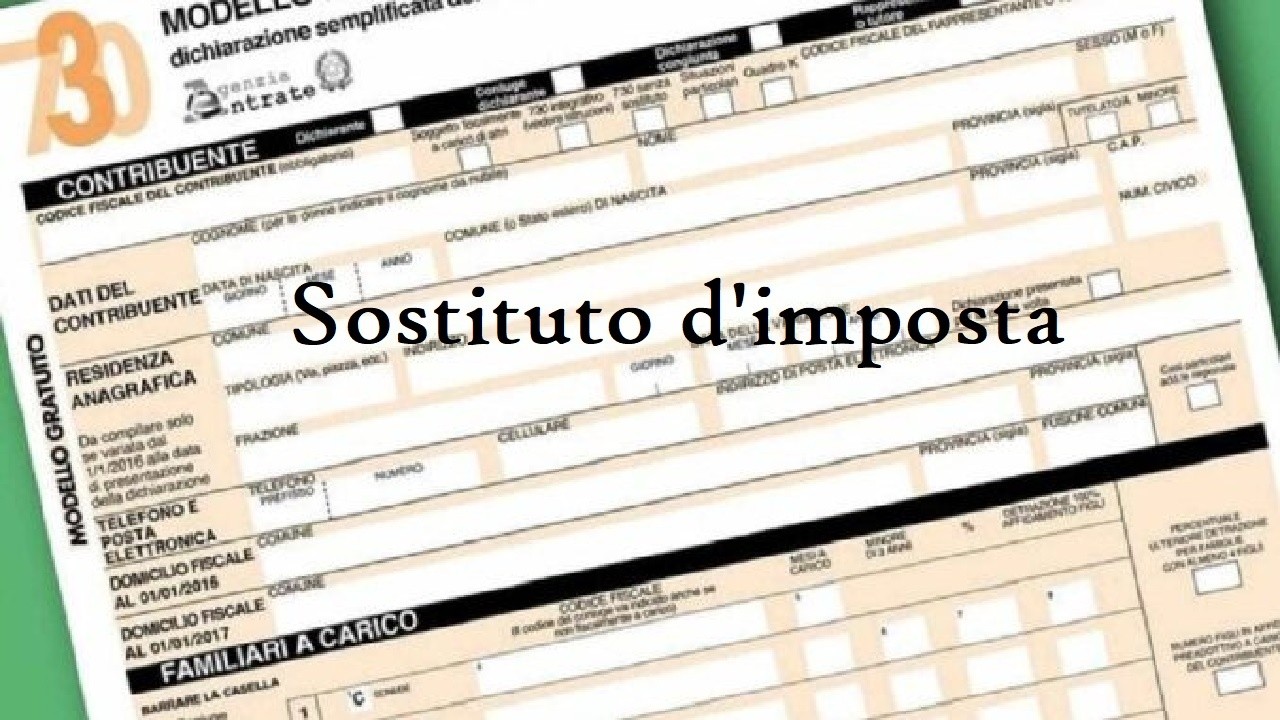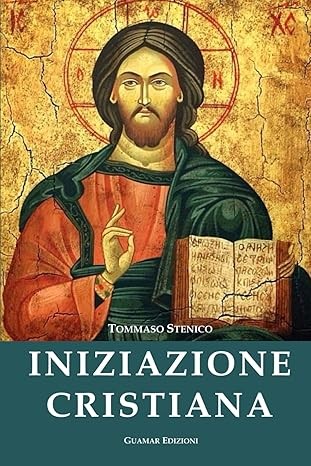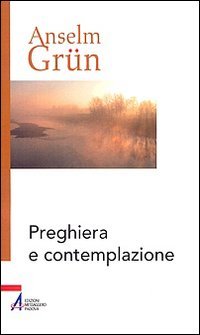di Tommaso Stenico
Vede la luce il primo documento di Leone XIV. Un progetto del suo predecessore, Francesco, che il Papa agostiniano ha fatto suo. Un testo elaborato congiuntamente da due Papi, come già era avvenuto con l'enciclica di Francesco Lumen fidei del 2013, ideata e avviata da Benedetto XVI.
L'amore per i poveri è il tema di questa esortazione apostolica, articolata in cinque capitoli e 121 punti. Attraverso questi, Papa Leone XIV esplora l'amore che la Chiesa ha manifestato per i poveri, mandato di Cristo stesso, nel corso della storia. Un amore che risale addirittura alla fondazione della comunità cristiana stessa, nell'Antico Testamento.
In realtà, l'intero testo è una constatazione del rapporto tra l'amore di Cristo e la chiamata a raggiungere i poveri. Un cammino di santificazione, afferma Leone XIV, "sul quale ritengo necessario insistere". Così, egli sottolinea in vari modi che l'amore per i poveri, o l'opzione preferenziale per loro, non è beneficenza o mero atto sociale, ma anche dottrinale, "a causa della natura cristocentrica di tale fermento".
Per Leone XIV, in questo senso, ci troviamo nell'orizzonte della Rivelazione, poiché «il contatto con coloro che non hanno né potere né grandezza è una via fondamentale per incontrare il Signore della storia».
«L'opzione preferenziale per i poveri, l'amore della Chiesa per loro, come ha insegnato san Giovanni Paolo II, è decisivo e appartiene alla sua tradizione costante. Esso la spinge ad affrontare il mondo in cui, nonostante il progresso tecnico ed economico, la povertà rischia di raggiungere proporzioni gigantesche», afferma in un altro punto.
Ma di più, sottolinea il Pontefice, questo amore per i poveri «genera uno straordinario rinnovamento sia nella Chiesa sia nella società, quando riusciamo a liberarci dall'autoreferenzialità e riusciamo ad ascoltare il loro grido».
Un grido «che interpella costantemente la nostra vita, le nostre società, i sistemi politici ed economici, e soprattutto la Chiesa». Un mondo, denuncia il Papa, in cui i ricchi, che vivono in un'altra dimensione, lo sono sempre di più, mentre cresce esponenzialmente anche il numero dei poveri.
"Persiste ancora, a volte ben mascherata, una cultura che ignora gli altri senza nemmeno rendersene conto e tollera con indifferenza milioni di persone che muoiono di fame o sopravvivono in condizioni indegne dell'esistenza umana", continua.
Per questo motivo, il Pontefice esorta a non abbassare la guardia di fronte a situazioni particolarmente gravi, come la mancanza di cibo o di acqua, o altre circostanze che colpiscono anche i Paesi più sviluppati. Egli invia un messaggio inequivocabile ai cristiani: «È impossibile dimenticare i poveri se non vogliamo essere esclusi dalla corrente viva della Chiesa che scaturisce dal Vangelo e feconda ogni momento storico».
L'amore di Dio per i poveri
Leone XIV dedica una parte significativa del documento a sottolineare come i poveri abbiano un posto speciale nella storia della salvezza di Dio, un'opzione che non è esclusiva, ma piuttosto compassione per la debolezza.
Si concentra in particolare sul Vangelo, dove possiamo vedere come la povertà abbia avuto un impatto su ogni aspetto della vita di Gesù. Ed è proprio Lui che viene a liberare i poveri. "Apre gli occhi ai ciechi, guarisce i lebbrosi, risuscita i morti e annuncia la buona novella ai poveri; Dio si avvicina, Dio li ama", aggiunge.
E per questo afferma che «la Chiesa, se vuole essere di Cristo, deve essere la Chiesa delle Beatitudini, una Chiesa che fa spazio ai piccoli e cammina povera con i poveri, un luogo dove i poveri hanno un posto privilegiato».
Questo amore privilegiato si è manifestato nel corso della storia, a partire dai primi cristiani, il cui programma di carità «derivava non da analisi o progetti, ma direttamente dall'esempio di Gesù, dalle parole stesse del Vangelo».
Molti uomini e donne nel corso della storia hanno seguito queste stesse parole, soprattutto congregazioni religiose, rispondendo a situazioni di fragilità e sofferenza.
Un atteggiamento sostenuto dalla riflessione dei Padri della Chiesa, i quali, secondo Leone XIV, «riconoscevano nei poveri un accesso privilegiato a Dio, una via privilegiata per incontrarlo». Così, egli riprende un'idea ripresa in altre sezioni: «La carità verso i bisognosi non era intesa come una semplice virtù morale, ma come espressione concreta della fede nel Verbo incarnato». Afferma inoltre: «La carità non è facoltativa, ma il criterio del vero culto».
E da buon agostiniano, porta Sant'Agostino nella sua riflessione per mettere in luce, tra le altre cose, l'elemosina, che «non è un gesto paternalistico, ma giustizia restaurata» di fronte alle strutture di accumulazione, riaffermando così la comunione come vocazione ecclesiale.
L'amore della Chiesa per i poveri
Il Papa concretizza questo amore per i poveri attraverso la risposta della Chiesa in diverse opere e ambiti. Nel campo dei malati, con i Fratelli di San Giovanni di Dio, i Camilliani, le Figlie della Carità, gli Ospedalieri... «La tradizione cristiana di visitare i malati, di lavare le loro piaghe, di confortare gli afflitti non si limita a una mera opera di filantropia, ma è un'azione ecclesiale», insiste.
E aggiunge: «Quando la Chiesa si inginocchia accanto a un lebbroso, a un bambino denutrito o a un morente anonimo, realizza la sua vocazione più profonda: amare il Signore là dove è più sfigurato».
Leone XIV non dimentica la vita monastica, in particolare quella del monachesimo benedettino, decisiva anche nell'ospitalità, «segno di una Chiesa che apre le porte, che accoglie senza chiedere, che guarisce senza esigere nulla in cambio».
Mette inoltre in luce la vicinanza ai prigionieri, che continua ancora oggi, dei Mercedari e dei Trinitari, che vedevano nel riscatto "non un'azione politica o economica, ma un atto quasi liturgico, un'offerta sacramentale di se stessi".
«Quando la Chiesa si inginocchia per spezzare le nuove catene che imprigionano i poveri, diventa un segno di Pasqua», aggiunge.
Elogia anche il contributo degli ordini mendicanti, così come delle congregazioni dedicate ai migranti e al campo educativo. Riguardo a quest'ultimo, sottolinea: "Per la fede cristiana, l'educazione dei poveri non è un favore, ma un dovere. I bambini hanno diritto alla saggezza, come requisito fondamentale per il riconoscimento della dignità umana".
In questo senso, con l'opzione per i poveri dei grandi santi, egli afferma che «la santità cristiana fiorisce spesso nei luoghi più dimenticati e feriti dell'umanità». «È in loro [i poveri] che la Chiesa riscopre la chiamata a rivelare la sua realtà più autentica».
E il capitolo conclude: "Tutti questi esempi insegnano che servire i poveri non è un gesto dall'alto verso il basso, ma un incontro tra pari, dove Cristo viene rivelato e adorato. Quando la Chiesa si inchina a terra per prendersi cura dei poveri, assume la sua posizione più alta".
Insegnamento sociale
L'ultima parte del documento è una rassegna della dottrina sociale da Leone XIII ad oggi, con riferimenti al Concilio Vaticano II e alla riaffermazione del destino universale dei beni, ai Papi e alla Conferenza episcopale latinoamericana di Medellín.
Anche Francesco, con il quale grida: «Dobbiamo continuare a denunciare la dittatura di un'economia che uccide e riconoscere che mentre i profitti di pochi crescono esponenzialmente, quelli della maggioranza si allontanano sempre di più dal benessere di quella felice minoranza».
In un messaggio rivolto a coloro che sostengono che il mercato si autoregola e che è solo questione di tempo prima che le disuguaglianze vengano corrette, afferma anche: "La dignità di ogni persona umana deve essere rispettata ora, non domani, e la difficile situazione di molte persone a cui questa dignità è negata deve essere un costante richiamo alla nostra coscienza".
E conclude: «Le strutture di ingiustizia vanno riconosciute e distrutte con la forza del bene, attraverso un cambiamento di mentalità, ma anche con l'aiuto della scienza e della tecnologia, attraverso lo sviluppo di politiche efficaci per la trasformazione della società. Bisogna sempre ricordare che la proposta del Vangelo non è solo quella di un rapporto individuale e intimo con il Signore».