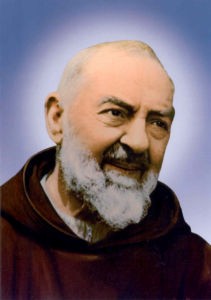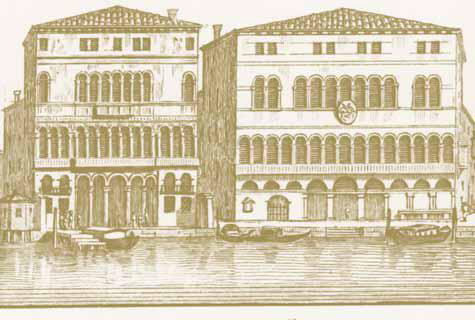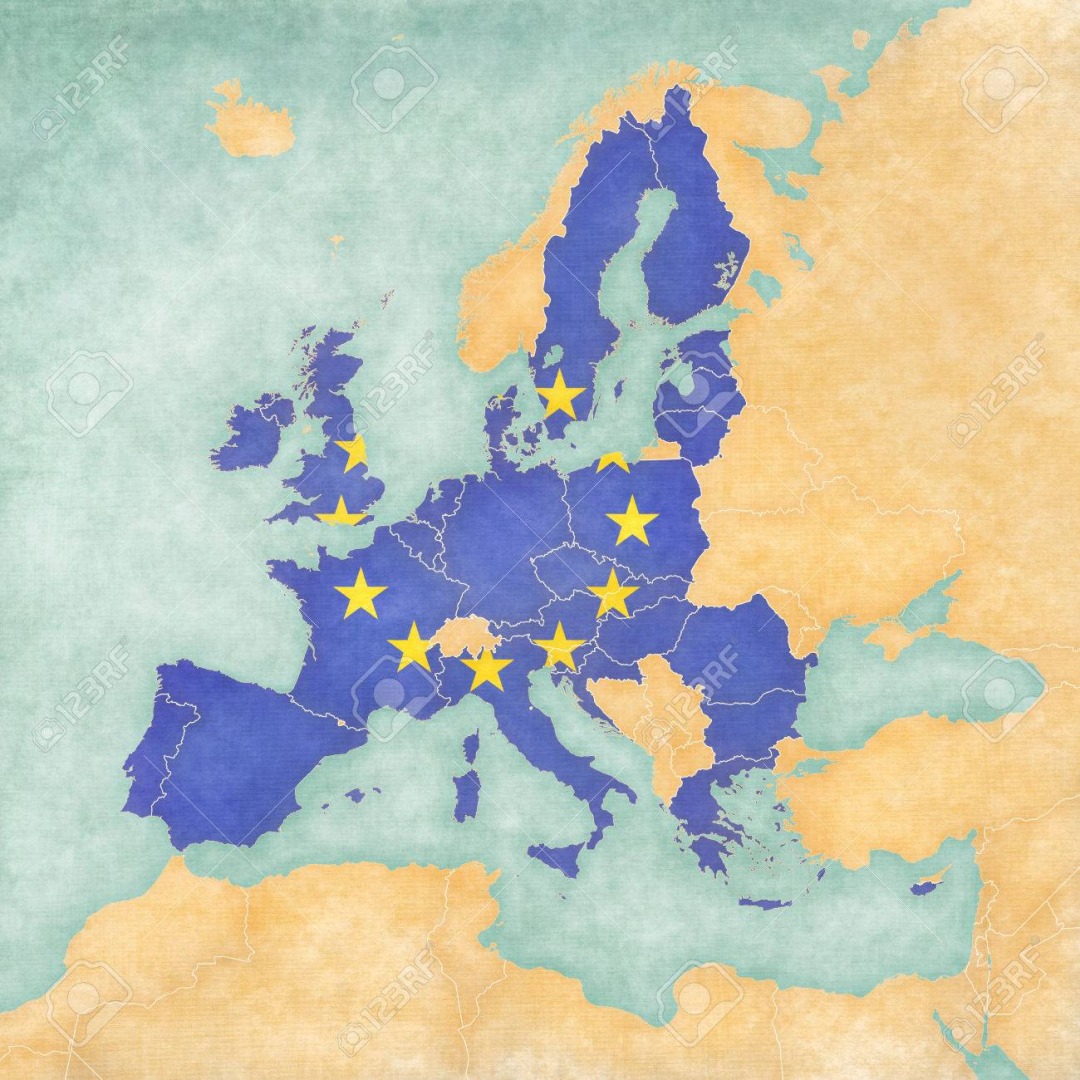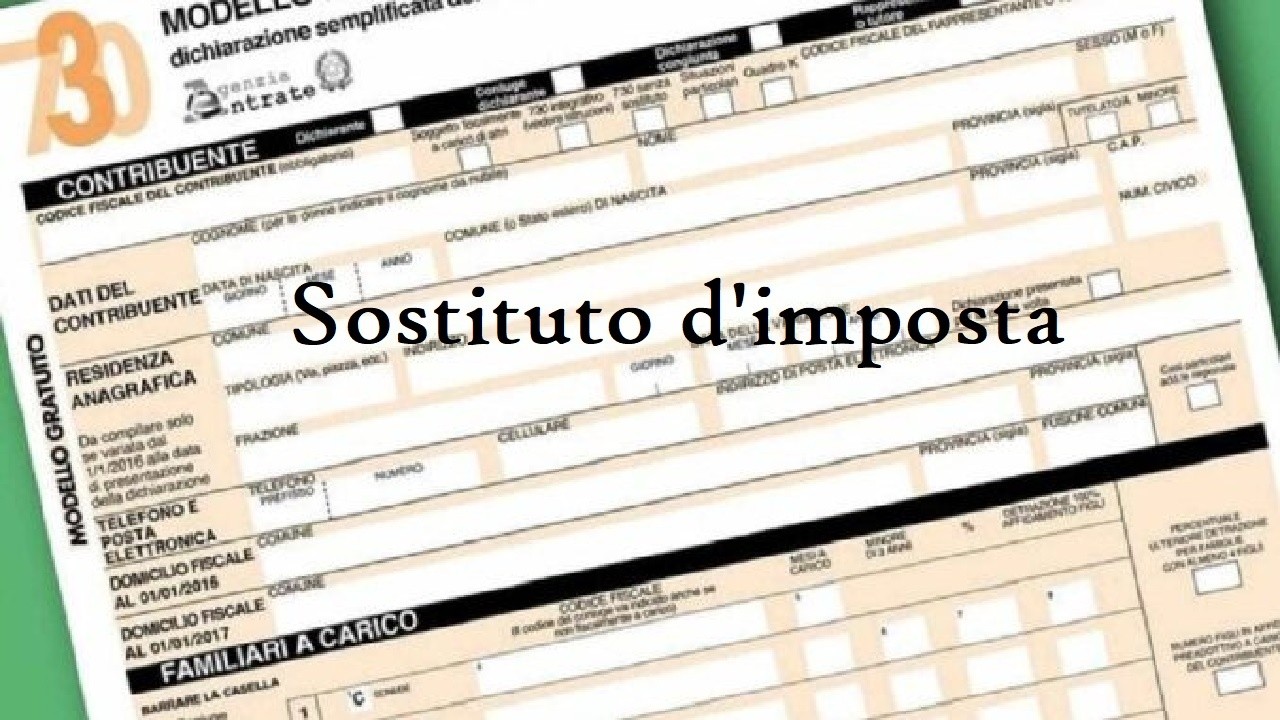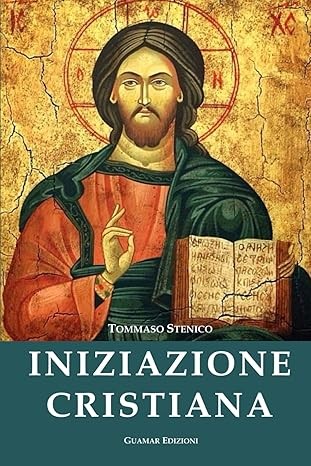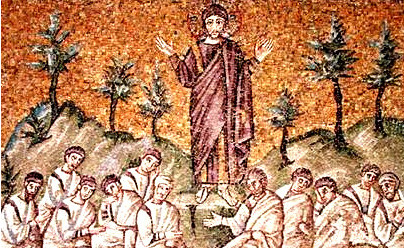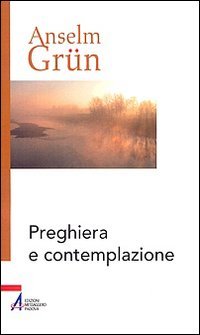di Ruggero Morghen
Centoquarant’anni or sono, il 18 aprile 1885, mons. Giuseppe Sarto, futuro papa san Pio X, faceva il suo ingresso nella diocesi di Mantova della quale era stato nominato vescovo l’anno precedente e dove avrebbe esercitato il ministero episcopale sino a buona parte del 1894. Il prelato di origine trevigiana il 6 novembre dell’anno precedente era stato consacrato all’episcopato presso la basilica romana di Sant’Apollinare per le mani del cardinale Lucido Maria Parocchi.
In questo anniversario “Corrispondenza romana” e Giuseppe Stevi ricordano nel Sarto il vescovo intraprendente, non distratto o sfuggente alle proprie responsabilità. Ciò, senza dimenticare – aggiungono – che “oggi la figura del vescovo non viene sempre e adeguatamente valorizzata e nemmeno messa nelle condizioni di esercitare, nelle sedi proprie e in maniera conferente, le responsabilità che le appartengono”.
La diocesi assegnata al Sarto è descritta come la più disastrata dell’Italia del tempo, con una partecipazione alla vita religiosa fortemente decaduta e il verificarsi, in più occasioni, di episodi denotanti un consistente abbandono religioso. Il clero mantovano, oltre che contenuto numericamente, appariva fortemente disorientato. Nel solo anno 1870, alla caduta del potere temporale del Papa, una decina di sacerdoti aveva lasciato il ministero e la quasi totalità dei secolari era ancora orientata verso idee rivoluzionarie o, come si diceva allora, “liberali” o “liberaleggianti”, venendo meno anche ai propri doveri sacerdotali.
Pochi anni prima dell’arrivo del futuro Pontefice, negli anni ’70, in diocesi di Mantova si era assistito ad una vera e propria rivolta presso tre parrocchie che invocavano di autodeterminarsi nella nomina del parroco. Questa situazione si dice fosse fomentata da orientamenti stranieri interessati a scardinare in Italia ogni resistenza alle politiche portate avanti dai governi del giovane Stato unitario. Tra questi orientamenti figurava il governo britannico di William Ewart Gladstone, il quale aveva visto nei fatti delle tre parrocchie del Mantovano «un risveglio del laicato che faceva sperare nella riforma democratica del cattolicesimo».
Lo stesso seminario, qualificato come il vero covo delle cennate idee “liberaleggianti” durante gli anni antecedenti l’unità d’Italia, oltre a presentare problematiche di carattere economico e gestionale, non era in grado di garantire un’adeguata formazione ai seminaristi che lo frequentavano. Era, appunto – scrive Gianpaolo Romanato -, il «seminario agonizzante; la pratica religiosa scesa a livelli bassissimi”. Lo storico aggiunge che in certe parrocchie i sacerdoti non predicavano più da decenni, in altre proliferavano le convivenze al di fuori del matrimonio, in altre ancora si stava perdendo l’abitudine di far battezzare i figli.
Facendo leva su pochi ma fidati collaboratori, mons. Sarto si concentrò sulla ricostruzione della diocesi di Mantova partendo dalle cose essenziali. Come la riorganizzazione del seminario e l’adeguato vaglio degli aspiranti al sacerdozio. In una lettera pastorale da lui indirizzata alla diocesi tre mesi dopo essersi insediato, il 5 luglio 1885, mons. Sarto scrive che «l’educazione dei chierici è la base della diocesi, in quanto che da loro soltanto possiamo avere i buoni preti, [e] questa è l’opera più degna che possa uscire dalle mani di un Vescovo».
La concreta applicazione di questa linea di condotta emerge in una lettera pastorale del 7 febbraio 1887, indirizzata alla diocesi in occasione della Quaresima. Il vescovo Sarto scrive: «Molti cristiani, che appena superficialmente conoscono la scienza della religione, e meno la praticano, pretendono dirigersi a maestri, dichiarando che la Chiesa deve ormai adattarsi alle esigenze dei tempi, che è affatto impossibile mantenere la primiera integrità delle sue leggi; che gli uomini più saggi e più pratici saranno d’ora innanzi i più condiscendenti: quelli, vale a dire, che sapranno sacrificare qualcosa dell’antico deposito per salvare il resto». E continua parlando di un «moderno cristianesimo» dove è «dimenticata l’antica follia della croce, i dogmi della fede devono modestamente adattarsi alle esigenze della nuova filosofia». Precisa, inoltre, che «la morale evangelica troppo severa deve presentarsi a delle compiacenze, a degli accomodamenti» e che tali «massime si vanno divulgando non già dai suoi nemici aperti e dichiarati, ma da quegli stessi che si dicono figli della Chiesa, i quali, dopoche ne combattono e vilipendono le leggi, si offenderebbero se venissero segnati come disertori».
«È mancare di fede e di rispetto alla Chiesa il voler sostenerla coi nostri corti giudizi». «Il Vescovo – conclude – che ha ricevuto dal Cielo l’obbligo non solo d’esortare, di supplicare, di riprendere, ma ancora di prevenire, di nuovo vi ripete: state in guardia, e allontanatevi da quelli che in qualunque modo vorrebbero arrogarsi l’ammissione di consigliare, di decidere sulle concessioni che dovrebbe fare la Chiesa ai pretesi bisogni dei nuovi tempi».
Si staglia qui la figura di un pastore la cui azione evangelizzatrice – sottolinea Stevi - rifulge discreta e concreta, particolarmente attraverso la valorizzazione e il vissuto dei sacramenti affidati da Nostro Signore alla Chiesa.